I N C O N T R I P O M E R I D I A N I
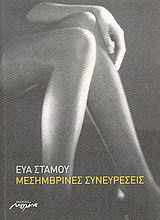
Eva Stamou, Incontri pomeridiani, Melani Edizioni.

In anteprima
il racconto La mappa
tratto da
Incontri pomeridiani
di Eva Stamou,
tradotto da Giorgia Karvunaki
L a m a p p a
L' umidità e l'odore della carne umana avevano imbevuto le pareti, il pavimento di legno, le tende macchiate. Tutto emanava un senso di marciume nauseante. La luce rosa della lampada spoglia, appesa al soffitto, crea ombre poderose che dividono la stanza in molti livelli fino all'ultima immersione che sprofonda in un letto grande, mezzo sgangherato, con coperte color viola. Di fronte, la televisione, accanto, il bar e una poltrona rossa mal assortita.
L’albergo si trova vicino ai binari del treno, un edificio che sembra fatiscente, in un quartiere che il tempo l’ha sorpassato. Sono nata in questa grigia città dell'Europa centrale, quarantotto anni fa. Dalla finestra del secondo piano arrivano alle mie orecchie voci ruvide, maschili - parole forestiere, slave. Così come si confondono l'una con l'altra, hanno una metodicità selvaggia che eccita i sensi.
Non vado mai a letto con uomini belli. Non oserei mai rivelare questo corpo, sottoponendolo davanti allo sguardo arrogante di un maschio ben fatto. L'uomo che è con me stasera, è un uomo stanco dalla vita, di quelli che non guardi una seconda volta. La notte che l'ho incontrato, girovagava per le viuzze intorno alla stazione come un cane randagio.
Non provo quasi nulla per lui, ma ci penso spesso. Lo immagino lavorare sui libri della contabilità in un ufficio non soleggiato, da qualche parte nel centro della città. Lo immagino rientrare in una casa altrettanto buia e abbandonata, riscaldare al forno a microonde il pasto semi preparato quasi pronto, comprato al supermercato, finendo la serata davanti alla televisione a guardare il notiziario di mezzanotte.
I suoi capelli sono radi e grassi, la barba piena di peli bianchi, il corpo flaccido, appassito.
Guardo i suoi piccoli occhi verdi, bagnati e torbidi dalla fatica della giornata, e al loro interno posso vedere passeggiate notturne per le strade principali con i cabaret, bottiglie vuote di vino di scarsa qualità, accatastate sul minuscolo balcone della cucina, porta ceneri strapieni, buste marrone piene di dichiarazioni fiscali, una ventiquattrore logorata, pile di giornali sportivi che coprono il mosaico sbiadito del soggiorno.
Posso ancora vedere nel profondo dei suoi occhi rinunce, offese, gelosia, rabbia soffocata e la gelida sensazione di frustrazione.
Ogni mattina quando mi sveglio, monto me stessa. Mi pettino, mi trucco, indosso un reggiseno e un corsetto, affettando il mio corpo in curve piccole e attraenti, superfici sottomesse all’apparenza. Ogni mattina quando mi sveglio, mi decoro con gioielli, mi metto il profumo, salgo su tacchi alti, creando ciò che voglio che vedano gli altri. Copro la verità della carne e scelgo una mia verità, modifico me stessa, smonto e ricreo la mia immagine secondo l'umore e la forza della giornata. Conservo i miei segni, i miei emblemi solo per me stessa, li tocco di notte appollaiata sul mio letto singolo.
Voglio raccontare la mia storia, la storia del mio corpo. Voglio denudarmi davanti ad occhi sconosciuti, davanti a dita estranee che seguiranno i segni delle ferite. Mi sono stancata di nascondere le mie magagne, i miei difetti, le mie deformità. Voglio parlare in quanto il mio corpo, così diverso dagli altri, ha il diritto di essere ascoltato. Voglio parlare perché i corpi che non vengono ascoltati, non riescono a trovare pace.
Ogni mattina monto me stessa, monto i miei pezzi, mi travesto da donna normale, ordinaria, una di quelle che circola spensieratamente al centro della città e si pavoneggiano compiaciute della loro immagine riflessa nelle vetrine dei negozi, una di quelle che a casa le aspetta il loro marito che le desidera, ragazzi piccoli che hanno bisogno di loro, genitori anziani che le ammirano. Queste donne, le piccole regine che camminano accanto a me, così diverse da me, mi assomigliano solo esteriormente. Le nostre vite, il nostro passato e il nostro futuro non hanno nulla in comune. I nostri corpi, nudi, senza i vestiti che li coprono, sono tanto diversi quanto diverse sono le cose che possono riuscire a fare. Il mio corpo si tiene in vita da pillole e macchinari, i loro hanno la capacità di portare al mondo nuove vite. I loro corpi ispirano soggezione, la mia compassione.
Porto il mio corpo come un carico, un peso staccato da me, un bagaglio di cui non posso fare a meno. È un pezzo di una materia con caratteristiche precise che cambiano tanto da non lasciare agli altri il dubbio che riguarda la stessa persona. È uno specchio di stati d'animo, sensi ed emozioni, un'identità da cui potermi riconoscere.
Il mio corpo è una mappa. Pelle dipinta dal mio passato, dalla mia storia, dai miei giorni e delle mie notti tra persone. Il mio corpo è una mappa incisa, contrassegnata da un capo all'altro: vene, arterie, lividi, smagliature, scolorimenti e linee di espressione. Segni e confini. Confini tra corpi, tra verità e immaginazione, tra vita e morte. Linee visibili e invisibili che circoscrivono, proteggono, vietano.
Sono il risultato del tempo che ho usato, e come esso si è modellato sul mio corpo.
Mi vergogno del mio corpo, del tempo che lo sciupa, dello spazio che occupa. La carne teme la verità, la convivenza con il tempo, teme più della morte, le sue ferite.
Ci sono volte in cui trovo difficile convivere col mio corpo, un corpo che mi ha tradito così tante volte, un corpo che ho abbandonato così tante volte, e altre tante ho lottato per tenerlo in vita.
Odio la mia carne pigra e insaziabile, ho paura della sua memoria.
Il mio corpo è una mappa, incisa dal dolore e dalla malattia. Una rete di vene, tagli, segni, cicatrici vecchie e nuove, incisioni profonde che l’emodialisi ha lasciato sulla mia pelle.
La geografia del mio corpo cambia, si trasforma col tempo, il petto si abbassa, i fianchi si allargano, piccole linee bianche attraversano la pelle all'interno delle cosce, lì dove una volta c'era carne rassodata, piccole macchie marroni compaiono sul mio viso, una volta bianchissimo. Piccoli cambiamenti graduali, piccoli cedimenti. La materia cede al tempo, come cede il mio orgoglio alla gente. Di giorno in giorno mi trasformo in una persona che non sono io.
Il mio corpo è una mappa, io sono una mappa. Potrei stare nuda in una galleria di arte contemporanea e le persone potrebbero passare e leggermi, studiare il mio presente e il mio passato. È tutto qui: le cicatrici e i buchi degli aghi che uniscono il mio corpo con la macchina dell’ emodialisi, le vene rotte, i lividi. Starò in piedi, a testa alta, lo sguardo fisso al soffitto - non oserei guardare il pubblico negli occhi - il mio corpo dritto, interamente inciso, lavorato da un’estremità all’altra dagli strumenti dei medici. Scultura carnosa. "Work in Progress" scriverebbe il cartellino messo sul muro sopra la mia testa.
Sono una mappa carnosa.
Lo aspetto alla stazione. Nascondo il mio viso in modo goffo dietro le pagine del giornale. Sguardi sporchi, sfocati, folla volgare. Gente che va e viene, carica di valigie passate di moda, borse di pelle morbida, buste dei negozi intorno alla stazione, pacchi piccoli e grandi. Spostamenti. Indietro avanti, avanti indietro, come le lancette dell’orologio, e tutti hanno in mente il ritorno. Io, rassegnata ad ogni tipo di spostamento, sto, tra loro, sulle mie scarpe di vernice nera. I miei percorsi sono completamente materiali, confinati nel deserto della città dei mille colori, insegne e lampioni. Nulla di sostanzioso cambia davvero all’umore e alla mia quotidianità. Intrappolata in una vita di un essere vivente solo.
Esco da casa e mi dirigo verso la stazione. Tempo piovoso, autobus, macchine, persone che camminano su e giù, una massa grigia e inestricabile che va e viene verso di me. Il rumore della strada mi riporta alla realtà, collegandomi all'esterno ma anche con la mia parte interiore: con ciò che sento. Giornata buia e triste, mi sono arresa alla stanchezza senza resistenza, alla stanchezza che m’impedisce di pensare, di chiedermi a causa di chi e di che cosa la mia vita è un interminabile esercizio di solitudine e rinunce. Mi fermo bruscamente in mezzo alla strada, chiudo gli occhi: non è da me essere melodrammatica. Apro gli occhi e lo vedo scrutarmi con sguardo furbo, perquisendomi dalla testa ai piedi. Mi chiedo da quanto tempo aspetta all'angolo della strada. Lui si avvicina ed io lo sorpasso.
Central Station Hotel: vita stretta, limitata all’indispensabile. Stanza numero dodici, secondo piano, ogni giovedì dopo il crepuscolo - un altro aspetto della solitudine.
Mi siedo al bar di una libreria accanto alla stazione e lo aspetto. Socchiudo gli occhi, creando un intralcio al contatto ottico con l'ambiente. Sento di vedere tutto da lontano, filtrato attraverso la ristrettezza del mio sguardo, come in un’allucinazione. Un sacchetto di plastica, bianco, I Love New York, latte di diversi gusti in grandi bicchieri di plastica. Libri, copertine, giornaletti. Il giovane cameriere mi sorride. Odore di cioccolata calda e caffè con cannella. Sguardi e passi affrettati. La macchina del caffè ferisce le mie orecchie. Maglioni, impermeabili, titoli di libri, nomi di diversi tipi di caffè e altre bevande. Copertine di plastica e bicchieri di plastica: sentimenti di plastica. Grande varietà e sfumature di sentimenti serviti allo stesso modo, con lo stesso sapore di solitudine, monotonia, vita indifferente e noiosa in così tante forme diverse.
Apro gli occhi. È seduto proprio di fronte a me. Il suo aspetto è calmo, sottomesso. Tiene in mano una grande tazza bianca senza bere. Mi guarda in modo inesprimibile e aspetta un mio cenno.
Ripetizione. Parole, movimenti, azioni senza niente di nuovo e autentico. Materiale riciclato. La luce nella mia mente trema minacciosamente – in modo confortante. Si accende e si spegne e i pensieri e i significati cambiano colore. Anni di stanchezza mettono a mollo la mia anima in un liquido opaco e grezzo. Bile. L'universo gocciola la sua bile ed io la assorbo. Un’esistenza in più velenosa, una vita amara in più. Strofino un cubetto di zucchero tra le dita della mano destra. Il tavolo si riempie della fine polvere bianca. Mi piego e la soffio delicatamente. Che cosa posso mettere in bocca per addolcire la mia lingua avvelenata, la mia mente avvelenata? Coltello in vena immerso profondamente per far scorrere il sangue sporco, malato, per liberare i miei succhi, per farli traboccare, per riempire il mio cervello d’immagini e forme, parole e sogni, per entrare in movimento, il mio organismo intorpidito, sfasato, ricominciare a sperare di nuovo.
Bendo gli occhi e dipingo con l’immaginario il macchinario dell’emodialisi.
Vivo con la consapevolezza che nessuno tenterà di disturbare la mia solitudine. La mia solitudine è la solitudine dei negozi di lusso e dei caffè moderni, la solitudine dei viaggi in treno dalla mia città verso altre città, la solitudine degli alberghi costosi, delle mattinate piovose davanti alla finestra e davanti alla TV. La mia solitudine è fatta d’immagini colorate che si susseguono in fretta. Vita protetta dall'attrito quotidiano di relazioni strette e conversazioni che non portano da nessuna parte. Anima protetta dalla desolazione vera, crudele e profonda che si prova quando si ama.
Il tempo scorre senza cambiare nulla. Il tempo è come un muro pesante, immobile – che mi è impossibile spingere, com’è impossibile cancellare la sua esistenza. La mia mente è così stanca che ho perso la meta e il motivo. Il mio corpo è così stanco che non riesco a trovare la forza per resistere a ciò che verrà in seguito. Mi sveglio ogni giorno in un mondo ostile e incomprensibile. Vivo e respiro portando in giro lo stesso stralunato riflesso. Nella mia mano sudata stringo la bottiglietta con le pastiglie.
Vertigine. Tutto gira intorno ed io immobile sto lottando per mantenere il mio equilibrio. Le pastiglie, le piccole pastiglie blu e quelle arancioni difficili da deglutire, sparse sul tavolo nero di cuoio, formano strane forme sotto la luce gialla della lampada. Sto barcollando. La mia mente gira, ma tutto il resto è statico, bloccato, non so, dove aggrapparmi. Vertigine. Il sentimento di nausea mi accompagna da anni ormai - impossibile ricordare me stessa senza di essa. Inchiodo i piedi sul pavimento di legno con smania, limito il pensiero, raccolgo la mia immaginazione, devo, ho bisogno di aggrapparmi a qualcuno o qualcosa, di non lasciarmi trascinare. Controllo il respiro, chiudo gli occhi, piego la testa, stringo il corpo per trattenermi, non disperdermi. Ciò che conta è rimanere intera fino alla fine, la fine dell'ennesima crisi di vertigine. Chiudo gli occhi, trattenendo lo stomaco - il centro dell'esistenza - con entrambe le mani, sorrido a me stessa per rassicurarmi, mentre cerco di raddrizzare la schiena, per ritornare alla mia posizione iniziale. L'importante è ritornare alla nostra posizione iniziale.
Cerco di rimanere nel ruolo dell’osservatore, anche se ciò che voglio davvero è vivere l'esperienza, l'essenza delle cose e non il loro involucro, non la parte esteriore della realtà, ma la parte dolce, morbida del centro della vita quotidiana, che mi avrebbe permesso di immergermi nei piccoli movimenti ripetitivi che compongono la vita.
Mi verrà dietro fino all'albergo. Salirò io prima e pochi minuti dopo busserà alla porta con esitanza. Mi alzo dalla poltrona rossa, gli apro, ci guarderemo per un momento senza scambiarci una parola e poi mi sposto per lasciarlo entrare. Ho bisogno di aggrapparmi da qualcuno o qualcosa, per non trascinarmi, per non disperdermi. Ogni settimana le stesse mosse, nello stesso ambiente, come in una scena teatrale. I mobili sono sempre impolverati, il rubinetto del bagno gocciola, il letto sgangherato scricchiola sotto il peso dei nostri corpi. Ciò che conta è rimanere intera fino alla fine, la fine di un'altra crisi di vertigine. Mi guarda taciturno e, con movimenti lenti, sistema le sue cose sul tavolino sotto lo specchio. Non ho mai chiesto cosa porta nella sua ventiquattrore, nei sacchetti dei magazzini che tiene di solito, nelle buste marroni che si porta sotto l'ascella. Getta il suo cappotto consumato sul bordo del letto e si avvicina a me. Chiudo gli occhi, trattenendo lo stomaco - il centro dell'esistenza - con entrambe le mani e gli sorrido per rassicurarlo, mentre cerco di raddrizzare la schiena, per ritornare alla mia posizione iniziale. L'importante è ritornare alla nostra posizione iniziale.
Non conosce il mio nome, non me l’ha mai chiesto. Di notte mi chiama ‘Ester’. La sua pronuncia è pesante, probabilmente tedesca, parliamo comunque sempre nella mia lingua. Accende una sigaretta e me la dà. Fumo solo quando siamo insieme. Il fumo riempie la stanza, mi offusca gli occhi. Ore dopo, quando si addormenta, rimarrò sveglia a osservare il suo viso, ascoltando il suo respiro pesante, aspettando. Presto incubi disturbano il suo sonno, ’Ester’ dice a voce alta,’Ester’ e le sue mani cercano il mio corpo nel buio. ‘Ester’ - e poi silenzio.
Prima di dormire a fianco a fianco, tenendoci per mano, prima di fare l’amore, ci togliamo i vestiti e tremando ci mettiamo uno di fronte l'altro, ogni settimana. Mentre mi si avvicina, lacrime riempiono i miei occhi, si fermano per un po’ nelle orbite degli occhi e poi scivolano giù per la gola. Mi guarda attentamente solo per un momento, prima di iniziare a dire con la sua voce rauca, incrinata: ‘Il tuo corpo è una mappa ...’

Eva Stamou
è scrittrice, editorialista su vari giornali ateniesi e dott.ssa in psicologia. Ha rappresentato la Grecia a festival internazionali del libro. Il suo lavoro comprende quattro romanzi, due raccolte di racconti e due saggi. Il racconto ‘La mappa’ fa parte della raccolta di racconti Incontri pomeridiani, ed è stato tradotto in inglese e lituano. Il racconto ‘Un piano perfetto’ è stato tradotto in danese. Il suo romanzo ‘L’escursione’ sarà pubblicato in arabo dalla casa egiziana Sefsafa nel 2020. http://evastamou.blogspot.com/

Fotografia di Nikos Mourkogiannis
Giorgia Karvunaki
(www.giorgiakarvunaki.com) è nata in Grecia, a Creta, a Canea. Ha studiato Scienze Politiche - Indirizzo Internazionale, Lingua e cultura italiana per stranieri, Insegnamento dell'italiano come lingua straniera e Sceneggiatura in Italia e Traduzione - Traduttologia in Grecia.
È membro associato e National Convener per la Grecia dal 2007 della Commissione internazionale per la storia delle istituzioni rappresentative e parlamentari (ICHRPI), Rappresentante accreditata del Nosside, Premio Internazionale di Poesia che è sotto l'Egida dell'Unesco e membro dell'International Theatre Institute (ITI).
Vive ad Atene dove lavora come traduttrice, promotrice culturale e ricercatrice storica. Le sue traduzioni di opere teatrali sono state messe in scena in Grecia e in Italia. Nel 2018 è stata premiata dall' Istituto Italiano di cultura di Atene con il Premio Luigi Pirandello. I suoi articoli, le sue traduzioni e le sue interviste sono stati pubblicati in riviste cartacee ed elettroniche in Grecia, in Italia e in Romania.
La pagina viene presentata per gentile concessione dell'autore, autrice, traduttore, traduttrice a Pioggia Obliqua