L A P A G I N A
di
M A R C O M A R C H I

Un Pasolini dantesco tra corpo e storia
All’altezza cronologica della Religione del mio tempo
– raccolta alla quale i versi di Alla mia nazione che oggi rileggiamo
appartengono – , il glicine dell'omonima poesia non è più per Pasolini l’emblema di una pura esistenza
perennemente rinnovantesi come all’epoca dell’Usignolo della Chiesa Cattolica, ma il simbolo di una
verginità defunta: la resistente restituzione lirica di una consapevolezza oltranzistica, semmai, da mistico-razionalista
smentito. La poesia si prepara in realtà ad adattarsi agli esiti rigorosamente maturati all’interno del proprio esercizio: si appresta a subire il crollo, a sopravvivere, simulare, mimetizzarsi, pragmatizzarsi e magmatizzarsi, nascondersi – lei mito sfuggente, intonazione, ma
anche etimologicamente vento che soffia dall’esterno – in altre «forme della poesia».
Poesia in forma di rosa, intitolerà fra poco il poeta. Andar per fiori all’Inferno: nella Divina Mimesis (con umili «fiorucci», danteschi «fioretti», «fiorellini», con un pascoliano prato del
cosmo incontrato sul cammino) e in Petrolio (dove il glicine, con il suo profumo da rappresentazione sinestetica di una realtà lontana dalla realtà, farà testuali
apparizioni). Come per diffrazione – poesia del sesso in tempi di esaurimento repressivo e di incipiente permissivismo sociale – sboccia in ambito cinematografico Il fiore delle Mille
e una notte.
Ma poi verrà l’«abiura dalla Trilogia della vita», si stabilizzeranno una volta per sempre
toni espressivi terminali da Tetro entusiasmo, su un «cuore» ideologicamente accordabile in chiave marxista con
Gramsci prevarranno le «buie viscere» contro di lui. Pasolini in Petrolio scenderà
davvero all’Inferno, come nella vita e come in molte delle sue sterminate letture, dei suoi grandi riscontri letterari anche in Descrizioni di descrizioni saggisticamente convocati e resi efficienti: da Strindberg a Sade (Salò!), da Dostoevskij a Dante, secondo ulteriori iridescenze, adesso, di un Dante interpretato come grande veicolatore garante della possibilità
autoanalitica estrema in termini di poesia, se in chi elabora Petrolio – lo ha notato
con pertinenza Aurelio Roncaglia – «l’impulso più profondo non è di tipo oggettivo-narrativo, bensì d’intima
ricerca, dunque inclinato a un istintivo lirismo». Pasolini affonda il bisturi nel proprio corpo, fa della sua affilata ed
oltranzistica «autoanalisi» un’«autopsia».
Dante come sperimentazione del morire, del vedere e comprendere attraverso la morte. Lo scandalo si rinnova,
un’eretica, equivocata e inaccettata «forza del passato» si estremizza in forma
linguistica, in struttura, in genere letterario nuovo ambiziosamente intentato su base culturalistica dispiegata e di nuovo
contaminata (dalle Argonautiche di Apollonio Rodio a L’écriture et l’expérience des limites di Philippe Sollers); ma i termini essenziali del confronto si
ripropongono pressoché immutati, tra pressanti richieste ideologiche di pronunciamento e di giudizio ed esigenze di
testimonianza poetica, di intransigente, finale e ultramondana autorappresentazione conoscitiva in cifra di obbedienza poetica.
Un sogno visionario di bolge e gironi in cui il capire è «gioiosa cognizione del capire», dove i personaggi pare che parlino
una lingua «meravigliosa», più che mai poeticamente risonante e lucente, «in versi o in musica». E non si può non ripensare, a integrazione del discorso e per contrasto, magari
assieme ai versi accesamente polemici di Alla mia nazione che oggi si propongono, ai versi del
Glicine che già ad apertura degli anni Sessanta, all'interno di una raccolta in cui il tema civile, appunto, al pari che nelle Ceneri di
Gramsci esigeva risposte e ancora potentemente si stagliava, dicevano: «tra il corpo e la storia, c’è questa / musicalità che stona, / stupenda, in cui ciò
che è finito / e ciò che comincia è uguale, e resta / tale nei secoli».
Marco Marchi
Alla mia nazione
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico,
ma nazione vivente, ma nazione europea:
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,
governanti impiegati di agrari, prefetti codini,
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare
che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.
Pier Paolo Pasolini
(da La religione del mio tempo, 1961, ora in Tutte le poesie)
Siena, Betti editrice, 2021, due volumi inseparabili, 640 pp., euro 45
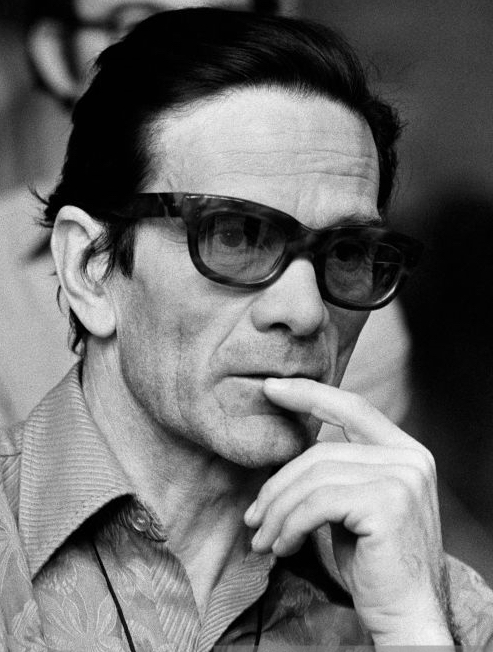
Rocco Scotellaro, il padre, la madre
Nell'opera poetica del lucano Rocco Scotellaro si impone costantemente l’urgenza di una comunanza: una comunanza che è tutt’uno con l’idea stessa di poesia come valore sociale, nel quadro di quel Sud arretrato e postbellico, ansioso di rivendicazioni e allineamenti, in cui la sua presenza letteraria e umana, da impegnato sindaco-poeta socialista di Tricarico (eletto nel 1946, quando Rocco aveva solo ventitré anni), si affermò.
Questa impellenza sinteticamente si articola e si lascia cogliere in un suo celebre testo dal titolo Sempre nuova è l’alba: «i vostri fiato caldi, contadini», «il nostro vento disperato»; e tra quei due possessivi un verso come «Beviamoci insieme una tazza di vino!», in cui linguisticamente la contraddizione esplode tra l'uso verbale riflessivo-popolaresco di quel «beviamoci insieme» e quella «tazza di vino» classicheggiante, da Alceo tradotto sub specie quasimodea.
Altrove l'esito contrappositivo è più piano, quasi didattico nell'ancor più evidente, concentrata giustapposizione dei suoi indicatori sensibili: «Mettete il vino, beviamo stasera» (La pioggia). E si ricordi la tarda Cena, scritta a Portici sullo scorcio del 1952, dove di nuovo a sera – ed è già memoria – il poeta dichiara di volersi sentire come un tempo ancora in compagnia. Con lo scarpaio, con il fabbricatore, con il sarto, Scotellaro recupera una forma di conciliazione psicologica con se stesso e con il suo gruppo d'appartenenza come altrimenti, in una ben diversa ma paragonabile circostanza storica foriera di novità, drammi e inedite possibilità di proiezione, Piero Jahier con sé e con gli alpini.
Sta di fatto che nella poesia di Scotellaro il «noi» aspira a diventare un istituto grammaticale resistentissimo, valido però per via di negazioni. Poeticamente la libertà del poeta è nel non potersi sentire sempre a casa, in famiglia, a un tavolo di cucina, parte di un insieme compatto, solidale ed antropologicamente individualizzabile.
«Profeta e apostolo di un risveglio contadino, voleva essere Rocco Scotellaro – notò suo tempo Vittorio Spinazzola –. Ma a trattenere questo empito c’era un’inquietudine invincibile, che lo respingeva dalla comunione attiva con gli altri nella solitudine frustrata dell’io». E ancora Spinazzola indicava nell’opera di Scotellaro, in versi e in prosa, «un punto di riferimento psicologicamente rivelatore nel ritorno assiduo dell’immagine paterna».
Il padre è un topos della poesia meridionale: basti pensare a Sinisgalli. Ma in Scotellaro, l'autore di È fatto giorno, Margherite e rosolacci, Contadini del Sud e L'uva puttanella morto precocemente all'età di trent'anni, il confronto con la figura paterna si dilata, assume rilevanza e significati su un più largo spettro nella misura in cui, nei più diversificati luoghi della sua scrittura, si parla di «fratelli» e «fratellastri», o si tiene scrupolosamente a distinguere tra «amici» e «fratelli» nell’impiego estensivo di un termine che rimanda alla vita affettiva: vita affettiva primaria e profonda, di tipo familiare e in primis genitoriale, larica, cui anche l'ancestrale e mitologica figura materna di Francesca Armento inevitabilmente, tra i «doppi» che la poesia plasma e porta alla ribalta, partecipa.
Padri amati e freudianamente odiati, sempre traditi e uccisi, e madri altrettanto amate e altrettanto dubitate e protestate, che metteranno in crisi a livello di conoscenza culturalizzata e di rivendicabile utilità civile del fatto letterario il rapporto di Scotellaro con l’esercizio della poesia: la sua stessa generosa e promettente ambizione, come scrisse Montale, «a diventare un letterato con tutte le carte in regola».
Marco Marchi
Ti rubarono a noi come una spiga
Vide la morte con gli occhi e disse:
non mi lasciate morire
con la testa sull'argine
della rotabile bianca.
Non passano che corriere
veloci e traini lenti
ed autocarri pieni di carbone.
Non mi lasciate con la testa
sull'argine recisa da una falce.
Non lasciatemi la notte
con una coperta sugli occhi
tra due carabinieri
che montano di guardia.
Non so chi m'ha ucciso
portatemi a casa,
i contadini come me
si ritirano in fila nelle squadre
portatemi sul letto
dov'è morta mia madre.
O mettetevi qui attorno a ballare
e succhiate una goccia del mio sangue
di me vi farà dimenticare.
Lungo è aspettare l'aurora e la legge
domani anche il gregge
fuggirà questo pascolo bagnato.
E la mia testa la vedrete, un sasso
rotolare nelle notti
per la cinta delle macchie.
Così la morte ci fa nemici!
Così una falce taglia netto!
(Che male vi ho fatto?)
Ci faremo scambievole paura.
Nel tempo che il grano matura
al ronzare di questi rami
avremmo cantato, amici, insieme.
E il vecchio mio padre
non si taglierà le vene
a mietere da solo
i campi di avena?
A una madre
Come vuoi bene a una madre
che ti cresce nel pianto
sotto la ruota violenta della Singer
intenta ai corredi nuziali
e a rifinire le tomaie alte
delle donne contadine?
Mi sganciarono dalla tua gonna
pollastrello comprato alla sua chioccia.
Mi mandasti fuori nella strada
con la mia faccia.
La mia faccia lentigginosa ha il segno
delle tue voglie di gravida
e me le tengo in pegno.
Tu ora vorresti da me
amore che non ti so dare.
Siamo due inquilini nella casa
che ci teniamo in dispetto,
ti vedo sempre tesa
a rubarmi un po’ di affetto,
tu che a moine non mi hai avvezzato.
Una per sempre io ti ho benvoluta
quando venne l’altro figlio di papà:
nacque da un amore in fuga,
fu venduto a due sposi sterili
che facevano i contadini
in un paese vicino.
Allora alzasti per noi lo stesso letto
e ci chiamavi Rocco tutt’e due.
Rocco Scotellaro
(da Tutte le poesie. 1940-1953, a cura di Franco Vitelli, Mondadori 2004)

Mario Luzi, la madre e Adonis
Sei anni fa, in occasione del decennale della scomparsa di Mario Luzi la città di Pienza ed il suo “Centro Studi la Barca”
stamparono, in collaborazione con l'Associazione svizzera di Mendrisio "Mario Luzi-Poesia nel Mondo” presieduta da Paolo Andrea Mettel, un'artistica,
raffinata plaquette dal titolo A mia madre dalla sua casa.
La pubblicazione era incentrata sulla traduzione in arabo che di questo splendido testo poetico di Onore del vero aveva fatto Adonis per omaggiare il poeta
amico e la città dei suoi soggiorni estivi da lui tanto amata (traduzione effettuata sulla versione in francese, anastaticamente riprodotta nell'originale arabo autografo), ma conteneva anche un
pregevole Collage analogamente dedicato (Adonis, com'è noto, è anche pittore, oltre che poeta), due bei ritratti fotografici dei due coprotagonisti e una nota di presentazione che avevo
avuto il piacere di firmare.
Luzi e Adonis: poesia naturale, del ritrovato accordo, e poesia dell’umano, alta poesia dell’umano. È a questo esaltante spartiacque che si situa, io credo, il più profondo, intimo ed implicante
incontro tra due poeti maiuscoli come Mario Luzi e Adonis: ed è questo, credo, il significato più intenso che la sua testimonianza in onore di Luzi e di Pienza viene ad assumere. Pluricandidato
al Nobel, Adonis – siriano d’origine, poi cittadino libanese, da molti anni francese, classe 1930 – è un poeta arabo di assoluto rilievo nel quadro della letteratura mondiale di oggi.
La sua opera, vasta, variegata, internazionalmente qualificata e molto tradotta – dai Canti di Mihyar il damasceno a Il teatro e gli specchi, dal Libro delle
metamorfosi e Celebrazione delle cose oscure e chiare a Un desiderio che avanza sulle mappe della materia e Memoria del vento –, ha presto
previsto la rottura degli schemi convenzionali della poesia arabo-islamica, facendosi portavoce, nell’innovare e nell’aprirsi a forme e valori universali, di una rinascita di quella tradizione e,
insieme, della difesa della libertà di pensiero e di espressione che sempre nel fatto artistico culmina.
Arte e senso dell’umano: trionfo dell’umano, attraverso la parola della poesia che ogni confine annulla e ogni barriera abbatte, e che ogni senso di fraternità ed ogni forma di comprensione, al
contrario, favorisce e suggella. Distante da ogni rigido confessionalismo e da ogni forma di ossequio al potere, parimenti critico nei confronti del cinismo dell’Occidente, Adonis ha sostenuto e
poeticamente interpretato con i suoi versi l’importanza della condivisione e della interrelazione fra le varie culture, valorizzando il senso di «opera comune» rivendicabile alla poesia, tra
ascolto del presente, memoria del passato e speranza.
Ha dichiarato qualche anno fa Adonis nel corso di un suo viaggio in Italia, siglando l’apertura a un collettivo e davvero globale «noi» dell’arte, rispettoso delle pluralità e delle differenze:
«Sì, sono d’accordo con Publio Terenzio Afro, Homo sum, humani nihil a me alienum puto; sono un uomo, non ritengo a me estraneo nulla di ciò che è umano». «A Napoli – ha detto ancora –
la tomba di Virgilio è accanto a quella di Leopardi, segno di una continuità che è anch’essa una forma di dialogo attraverso lo spazio e il tempo. In modo analogo, si può essere di religioni
diverse, ma quando vediamo la statua del Cristo velato di Giuseppe Sammartino nella Cappella Sansevero contempliamo un’espressione dell’arte umana. L’arte aiuta a portare tutto su un
piano di profonda umanità».
Virgilio come Leopardi, e Adonis come Luzi, nel nome dell’umano, nel nome di quei significati e di quei valori di cui troppo spesso l’umanità si dimentica. Questo i grandi poeti – in ogni luogo e
in ogni tempo, anche in un’epoca insensata, drammaticamente travagliata e disorientante come la nostra – ci insegnano.
Marco Marchi
A mia madre dalla sua casa
M'accoglie la tua vecchia, grigia casa
steso supino sopra un letto angusto,
forse il tuo letto per tanti anni. Ascolto,
conto le ore lentissime a passare,
più lente per le nuvole che solcano
queste notti d'agosto in terre avare.
Uno che torna a notte alta dai campi
scambia un cenno a fatica con i simili,
infila l'erta, il vicolo, scompare
dietro la porta del tugurio. L'afa
dello scirocco agita i riposi,
fa smaniare gli infermi ed i reclusi.
Non dormo, seguo il passo del nottambulo
sia demente sia giovane tarato
mentre risuona sopra pietre e ciottoli;
lascio e prendo il mio carico servile
e scendo, scendo più che già non sia
profondo in questo tempo, in questo popolo.
Mario Luzi
(da Onore del vero, 1957)

Pasolini incontra Pound
È stato Enzo Siciliano, in quello che resta con tutta probabilità il suo libro più bello, la Vita di
Pasolini, a testimoniare dell’iniziale indisponibilità di Pasolini a riconoscere la grandezza di Pound: diciamo pure della sua
insofferenza sub specie ideologica ad affrontare il caso, ad accedervi veramente tramite quella costituitasi chiave preferenziale deliberatamente bilanciata tra
'passione e ideologia' e così, in tali termini, efficiente. Una chiave d’accesso
soggetta tuttavia ai mutamenti del tempo, sensibile e storicizzabile anch’essa, instabilmente disposta a revisioni, calibrature e assestamenti, perfino in balia di stati
d’animo.
L’episodio narrato da Siciliano è rivelatore: «Quando lo conobbi, ed era il 1956, avevo appena scritto un articolo su Le ceneri di Gramsci, il singolo poemetto stampato nella serie
di “Nuovi Argomenti“ di Alberto Carocci e Moravia. Lo incontrai nella sua casa romana di via Donna
Olimpia. Mi chiese cosa leggessi, e gli parlai di Ezra Pound. Avevo letto e riletto i Pisan
Cantos. Mi accanivo a tradurre qualche stralcio da Rock-Drill 85-95 de los cantares. Ebbe una reazione furiosa: Pound razzista, fascista eccetera». «Quel primo incontro fra noi – continua Siciliano – andò male. Quanto a me, militavo a
sinistra: ma perché avrei dovuto negare che Pound fosse un grande poeta? In lui leggevo la tragedia della storia e dell’umanesimo vissuta dentro la barbarie della guerra dei nazisti e dei
fascisti, Pound era il barbaro penitente, messo tangibilmente a nudo nella gabbia di Pisa, un Whitman redivivo che ha perso e lasciato sfumare in
nero la panica bellezza del vivere».
E il problema fondamentale, l’interrogativo più inquietante e più bisognoso di risposte è proprio quello proposto dal giovane Siciliano: l’impossibilità di sacrificare sull’altare dell’ideologia l’autoevidente, luminosa e incontrovertibile grandezza di un autore. Siamo, si ricordi, a
metà degli anni Cinquanta: gli anni in cui Pasolini è un autore letterario, meglio un poeta, un poeta che a varie forme della poesia si affida, ma non ancora un regista; un poeta impegnato, un
poeta ideologizzato e già sufficientemente eretico e imbarazzante per i suoi, per la sua parte. Le ceneri di Gramsci non sono ancora diventati la raccolta edita da Garzanti (lo
sarà l’anno dopo), ma il tema della coniugazione storia-coscienza-poesia costituisce già per Pasolini un banco di prova ineludibile e prima ancora,
dopo La scoperta di Marx a suggello dell'Usignolo della Chiesa Cattolica, una base fondante.
C’era in Pasolini, detto in altro modo, nel Pasolini di quegli anni, la fiducia – sia pure drammaticamente contesta ed incrinata, dubitata e contraddetta – in una possibilità di incidere
sull’evoluzione stessa di quella Storia, di poter offrire un determinato contributo di collaborazione a un vero progresso umano, ad un progetto
migliorativo gramscianamente societario nel cui cerchio includere, come sempre in Pasolini potentemente e immancabilmente accade, le trame di una propria esistenza, di una propria visione in nero
(come in Whitman, come in Pound, a ben vedere), infera e invece desiderosa di luci, di trasparenze e iridescenze del vivere, di riscatti umani e prima ancora di compartecipazioni, di vicende
comuni (magari proprio quelle esaltanti concesse dalla poesia, sconfinate e inclusive, senza distinzioni tra la vita e la morte).
«Passarono gli anni – prosegue la rievocazione di Siciliano –. Pasolini incontrò Pound: ne risultò una testimonianza, mai più replicata, d’ottima
televisione, un’intervista. Nelle rughe, nelle sclere secche del vecchio Pound c’era lo sconvolgimento di un Occidente che si vedeva travolto dalle proprie stesse ragioni di
vita, nella propria sapienza conoscitiva. E Pasolini gli stava di fronte: le sue domande specchiavano una medesima disperazione, la stessa
apocalisse –, lontani entrambi da qualsiasi connotazione di ideologia e politica, entrambi vivi come esorbitanti poeti fuori norma,
disobbedienti a qualsiasi galateo di sanità letteraria, fiduciosi che la Storia comunque andasse per i propri strani sentieri avanti».
Ancora «geni a confronto», forse, come Cavalcanti e Pound, o come Dante e Pasolini, con uno stesso desiderio di conoscersi e di conoscere, di essere
vicendevolmente illuminati e rassicurati dalla propria genialità ‘singolare’, inevitabilmente separata e distante e insieme universale e rappresentativa proprio all’insegna della ispirazione,
della chiamata della poesia, di una stessa ansia a quella vocazione umanamente incaricata ed essenziale collegata. «Era una
duplice verità che veniva a galla – lo dice benissimo Siciliano –, due solitudini che si specchiavano e si
cercavano, più moderni di ogni moderno, fratelli che non sono più». E se è vero – come Siciliano conclude – che la poesia di Pasolini rischia
l’incomprensibilità «fuori dalla percezione della Storia del Novecento», è altrettanto vero che Pasolini non meno di Pound, effettuando la loro disobbedienza artistica, protestando, affermando
con coraggio davvero intrepido disappartenenze a molte cose del mondo nel nome e attraverso la poesia, in realtà obbediscono a richiami cogenti, a ragioni profonde. Sì, ardenti di libertà obbediscono, non possono che obbedire.
L’assenza nel poeta produce del resto presenza: una sorta di «mysterium mortis», per citare un titolo di Ladislaus Boros, una «kenosi del poeta»
tutt'altro che paradossalmente confidente nella capacità di esprimere se stessi e il mondo morendo a se stessi e al mondo. Esiliato e morto al mondo Dante, esiliato e morto al
mondo Cavalcanti (l'amatissimo Cavalcanti di Pound!), ma tutt’altro che scomparsi i frutti della loro applicazione, le cose viste dai loro strani, distanziati ed implacabili
sguardi. Il poeta conosce bene le condizioni notturne del suo operare; ha confidenza con questi stati della creazione in apparenza funerei,
sommersi e nostalgicamente attratti, e invece produttivi, vitali, generatori di illuminazioni, avanzamenti e aperture: tali anche nella «disperazione» in atto, nell’«apocalisse» vissuta da Pound
e Pasolini in corpo e anima, nell’intimo della loro irrefutabile «esorbitanza» artistica, della loro solitudine poetica imposta.
Ha scritto Ezra Pound a proposito di Cavalcanti nella sua Introduzione a tradotti Sonetti e
ballate, coniugando vita ed esercizio della poesia: «Dino Compagni, che lo conobbe, ci ha lasciato forse la più accurata descrizione dicendo che
Guido era “cortese e ardito, ma sdegnoso e solitario”, io almeno me lo raffiguro così. E così lo ritroviamo nelle sue poesie». Ha scritto a sua volta Pasolini, riferendosi a
Pound: «Pound chiacchiera nel cosmo. Ciò che lo spinge lassù con le sue incantevoli ecolalie è un trauma che lo ha reso perfettamente inadattabile a
questo mondo. L’ulteriore scelta del fascismo è stata per Pound un modo sia per mascherare la sua inadattabilità, sia un alibi per farsi credere presente. In che cosa è consistito questo trauma?
Nella scoperta di un mondo contadino all’interno di un mondo industrializzato, di molti decenni in anticipo sull’Europa. Pound ha capito, con abnorme precocità, che il mondo contadino e il mondo
industriale sono due realtà inconciliabili: l’esistenza dell’una vuol dire la morte (la scomparsa) dell’altra». E si dica soltanto se dietro a queste analisi e a questi giudizi
messi a confronto non si intravedano in ambedue i casi le filigrane dell’autobiografia, le consonanze e gli inevitabili differimenti
personalizzanti di ogni nostro pronunciamento.
Sconfinamenti, slittamenti, differimenti. Creature davvero strane, i poeti: creature tra fantasia e realtà, artificio e naturalezza, obbedienza a richiami cogenti e desiderio di libertà, infrazione delle regole e tensione a più ampie ed accettabili
dimensioni dell’esistere; e ancora creature solitarie e con gli altri, tremendamente attaccate all’ombelico della loro anima e insieme smaniose di orizzonti, con lo sguardo
concentrato su una carta piena di segni e nel contempo protesi sull’infinito…
«Lassù», come dice Pasolini, o «laggiù», come dirà in un’altra circostanza, poco importa. Di là, da quell’altrove, Pound e
Pasolini ascoltano suoni, i suoni di ciò che Pindaro chiamava la «cetra d’oro» e li trasmettono ad altri, umanamente li partecipano, li perpetuano, modulando le loro forme e i loro ritmi su
quella «cetra» che resiste, armonica e musicale, melodica e attraversata da mani, tutt’altro che da appendere ai rami, anche nella franta, disperata e apocalittica
modernità.
Ha dichiarato Pound intervistato non da Pasolini da Donald Hall a proposito della composizione
dei Cantos: «Il problema era trovare la forma (…). Doveva essere una forma tale da non eludere qualcosa solo perché non vi
si adattava». E ancora: «È difficile scrivere un paradiso quando è evidente che faresti bene a scrivere un’apocalisse»; e di nuovo, proprio in riferimento
a Villon e a Cavalcanti, musica e temi musicali che davvero si ritrovano in spartiti: «Volevo la parola e la melodia. Volevo della grande
poesia da cantare». Per mio conto vorrei solo aggiungere che mi è capitato una volta di intitolare uno dei miei saggi su Pasolini Moralità dell’indecenza, proprio a sottolineare, in
totale sintonia con la figura e con l’opera di Ezra Pound, la sua totale obbedienza alle ragioni oscure, misteriose e incoercibili della poesia.
Sosteneva Heine, un poeta, che dove le parole finiscono inizia la musica: come in Pound esemplarmente, testualmente accade, con l’interruzione dei versi
e con l’improvviso, inaspettato subentro di uno spartito. Heine affermava, volendo, una sorta di primato, ma per noi, soprattutto, sulla scia delle considerazioni sul ritmo
di cui scrive Ezra Pound occupandosi di Cavalcanti, un possibile parallelismo, una declinabilità di valore operativo: una verificabile, sinergica e determinante interazione in
cui le note dell’invisibile spartito del testo non solo seguono e inseguono l’effetto poetico, tendendo a ineffabili, affatto musicali e del tutto
scorporati traguardi della parola, ma agiscono nel corpo stesso di quella parola, nel suo farsi, nel suo costituirsi ed inverarsi, nel suo fisico incarnarsi come realtà.
Ed eccoci dove inizia la musica ma le parole non finiscono e anzi cominciano pure loro: in quei molto indagati e molto misteriosi spazi
dell’avantesto, in cui un’ispirazione musicale, sonora, fonica o addirittura intonazionale, è in cerca dei suoi significati, o in quelli analogamente ispirativi e già
concretamente generativi, in cui il processo in atto sembra ormai consistere: una sorta di danza e controdanza tra senso e suono, in un
necessitato, instabile ed esigente messaggio in fieri che progressivamente si definisce, e una
sua accettabile formalizzazione espressiva e comunicante, appunto, fino all’ispirazione che musicalmente non è affatto e per sempre un attimo, un momento raggiunto e subito imperituro, ma un
continuo, inesorabile e insoddisfatto variantismo di essere mutante. Un essere mutante perennemente pregato, corteggiato, inseguito e cacciato, destinato – come anche i percorsi di due ulteriori
«geni a confronto» certificano – a durare intere vite: intere vite di uomini-poeti.
E vengono a questo punto urgentemente in mente alcuni versi di Pier Paolo Pasolini datati 1966, anteriori di un anno rispetto alla celebre
intervista a Pound realizzata per la Rai nell’autunno del 1967 (il 23 ottobre) e dalla Rai trasmessa nel 1968 il 19 nell’ambito della
rubrica Incontri: versi provenienti da un dibattuto secondo Novecento della crisi, della ridefinizione poetica dei ruoli e
delle pertinenze, della caduta delle speranze e dell’accresciuta indecifrabilità moderna degli eventi. Pasolini si affida ancora all’io, a un io da autoritratto tragicamente storicizzato, avviato
ai traguardi crudelmente sfregianti da «tetro entusiasmo» di chi alla musica e alla poesia come a speranze totali si era per destino rivolto: ai suoni del «celeste Bach», ma
anche, con la musica di Bach promossa a esistenziale colonna sonora del reale, a quel fisico, anonimo e irresistibile «brusio della vita» che la sera molte volte, già negli anni giovanili e
prepotentemente narcissici di Casarsa, gli recapitava; lui il poeta settentrional-regressivo, pascolian-friulano di «Sera imbarlumida tal fossàl / a cres l’aga…» e del «nini muàrt», lui partecipe
e discusso testimone civile di eventi storici e intime eclissi ed apocalissi costantemente misurate tra corpo e musica, perso dietro all’apparizione cromatica di un glicine, di un semplice e
sontuoso albero che profuma.
«Io vorrei – ecco la sua voce di poeta spoglia e pedagogicamente atteggiata, ma che pure così ritrova la sua musica –
soltanto vivere / pur essendo poeta / perché la vita si esprime anche solo con se stessa. / Vorrei esprimermi con gli esempi. / Gettare il mio corpo nella lotta. / Ma se le azioni della
vita sono espressive, / anche l’espressione è azione. / Non questa mia espressione di poeta rinunciatario, / che dice solo cose, / e usa una lingua come te, povero diretto strumento; / ma
l’espressione staccata dalle cose, / i segni fatti musica, / la poesia cantata e oscura, / che non esprime nulla se non se stessa».
«Non farò questo con gioia. – continua l’autore non delle Ceneri di
Gramsci ma di Poeta delle Ceneri – Avrò sempre il rimpianto di quella
poesia / che è azione essa stessa, nel distacco dalle cose, / nella sua musica che non esprime nulla / se non la propria calda e sublime passione per se stessa. / Ebbene, ti confiderò, prima di
lasciarti, / che io vorrei essere scrittore di musica, / vivere con degli strumenti / dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare, / nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ariosto /
sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta / innocenza di querce, colli, acque e botri, / e lì comporre musica / l’unica azione espressiva / forse alta, e indefinibile come le
azioni della realtà».
Un rimpianto, la musica, e un desiderio inestinguibile; un poeta in una torre e un poeta in fondo a un pozzo (secondo l’intervista di Pasolini a
Pound, probabilmente svolgendo in quella immagine isolante, in ascolto e operosa, una suggestione di Eliot: la dedica in calce a The Waste Land), per via di concentrate verticalità contrapposte a distese vastità, a «ricordare», a «macinare» come dice Pasolini a Pound, o a «rimasticare», come dice Pound replicando,
il ricordo della propria vita.
Il giudizio di Pasolini su Pound è ormai chiaro, si è fatto adulto, trasparente, pronto sintonicamente e fraternamente a ridefinirsi a specchio di
un già avvenuto, autorizzante confronto da «odi et amo» come quello intrattenuto da Pound con Whitman; pronto a credere scandalosamente, oltre ogni abiura e ancora nel nome
della poesia, in agnizioni, trasformazioni, dialoghi: per «amore della vita» e nient’altro, se – come la poesia di Ezra Pound ci
assicura – «Quello che veramente ami non ti sarà strappato».
Marco Marchi
Dal Canto LXXXI
(Pull down thy vanity...)
What thou lovest well remains, the rest is dross
What thou lov'st well shall not be reft from thee
What thou lov'st well is thy true heritage
Whose world, or mine or theirs or is of none?
First came the seen, then thus the palpable Elysium, though it were in the halls of hell,
What thou lovest well is thy true heritage
The ant's a centaur in his dragon world.
Pull down thy vanity, it is not man
Made courage, or made order, or made grace, Pull down thy vanity, I say pull down.
Learn of the green world what can be thy place
In scaled invention or true artistry,
Pull down thy vanity, Paquin pull down!
The green casque has outdone your elegance.
«Master thyself, then others shall thee beare» Pull down thy vanity
Thou art a beaten dog beneath the hail
A swollen magpie in a fitful sun,
Half black half white
Nor knowst'ou wing from tail
Pull down thy vanity How mean thy hates
Fostered in falsity, Pull down thy vanity,
Rathe to destroy, niggard in charity,
Pull down thy vanity, I say pull down.
But to have done instead of not doing this is not vanity
To have, with decency, knocked
That a Blunt should open To have gathered from the air a live tradition
or from a fine old eye the unconquered flame
This is not vanity. Here error is all in the not done,
all in the diffidence that faltered.
(Strappa da te la vanità...)
Quello che veramente ami rimane, il resto è scorie
Quello che veramente ami non ti sarà
strappato
Quello che veramente ami è la tua vera eredità
Il mondo a chi
appartiene, a me, a loro, o a nessuno?
Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore
d'inferno,
Quello che veramente ami è la tua vera eredità
La formica è un centauro nel suo mondo di draghi.
Strappa da te la vanità, non fu
l'uomo
A creare il coraggio, o l'ordine, o la grazia, Strappa da te la vanità, ti dico
strappala
Impara dal mondo verde quale sia il tuo luogo
Nella misura
dell'invenzione, o nella vera abilità dell'artefice.
Strappa da te la vanità, Paquin
strappala!
Il casco verde ha vinto la tua eleganza.
«Dòminati, e gli altri ti sopporteranno» Strappa da te la vanità
Sei un cane bastonato sotto la
grandine,
Una pica rigonfia in uno spasimo di sole,
Metà nero metà
bianco
Né distingui un'ala da una coda
Strappa da te la vanità Come son
meschini i tuoi rancori
Nutriti di falsità. Strappa da te la vanità,
Avido di distruggere, avaro di carità,
Strappa da te la vanità, Ti dico, strappala.
Ma avere fatto in luogo di non avere fatto questa non è vanità
Avere, con discrezione, bussato
Perché un Blunt aprisse Aver raccolto dal vento una tradizione
viva
o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata
Questa non è
vanità. Qui l'errore è in ciò che non si è fatto,
nella diffidenza che fece esitare.
Ezra Pound
(da Canti Pisani, LXXXI, versi finali, traduzione di Alfredo Rizzardi)

Ricordo di Luigi Baldacci
L’indomani sarebbe stato il suo compleanno (il settanduesimo) e invece, a fine giornata, il 26 luglio 2002 la morte lo sorprese mentre stava finendo di cenare a casa di due amiche, al primo piano di quel palazzo di Via Pandolfini in cui da tempo abitava. Con loro, Anna e Paola, Baldacci aveva già condiviso un mazzo di fiori arrivati, inconsapevole di adornare così quella casa ospitale che nei giorni successivi sarebbe stata meta di tante persone affrante, di tanti ricordi e dimostrazioni d’affetto, abbracci e pianti.
La morte di Luigi Baldacci, fattasi subito notizia, sorprese tutti: riempì di dolore e di sconcerto soprattutto quegli amici che il giorno dopo avrebbero condiviso con lui – magari con una telefonata da lontano, dai luoghi di «vacanza» su cui Luigi amabilmente ironizzava, ritenendoli per sé, da tempo, impraticabili – l’altrettanto discutibile possibilità di poter festeggiare un anniversario, un traguardo raggiunto fattosi per lui con gli anni via via più preoccupante e pesante.
A far paura a Baldacci non era la morte, quanto piuttosto l’inevitabile, leopardiana «detestata soglia» di quella «vecchiezza» che chi non muore deve ad un certo punto conoscere, varcare.
Una soglia alla quale in realtà sembrava essere pervenuto molto presto: in ansioso anticipo sulle tabelle di marcia, o per meglio dire con la filosofica, premonitrice sicurezza che i suoi autori prediletti gli avevano indicato, e che cioè la vita non tarda a manifestarsi già vecchia a chi la sappia o la voglia vedere. Questo gli avevano senz’altro insegnato Leopardi e Tozzi, ma anche Pirandello, il sottovalutato e impopolare Arturo Loria, il fuori moda Palazzeschi, i suoi pittori “visti da vicino” e le sue maschere.
Baldacci aveva accolto questa dura prospettiva, la aveva fatta propria con l’intelligenza e la fermezza di cui era capace, riconducendo a questa ardua chiave di lettura del reale, da «male nell’ordine», pure ogni residua tozziana «distrazione» concessa: persino, in compagnia di Palazzeschi, l’irriverente trionfo del riso, o con la musica di Puccini e Mascagni o il Tristano di Wagner, la commozione.
Il tragicismo di Baldacci era però votato al paradosso, minato al suo interno da un’inesausta volontà di capire e di comunicare, nonostante certe apparenze e certe sostanze solitarie del suo modo di essere, del suo carattere culturalmente plasmato.
Così potevano biograficamente affermarsi e affascinare – oltre alla cultura sterminata e pressoché infallibile che ne ha fatto un critico tra i massimi del Novecento – anche gli aspetti un po’ selvaggi, scontrosamente appartati e fieramente autosufficienti che erano in lui, uomo di grande civiltà, di eleganza vera, di onestà e socialità ineccepibili in qualsiasi intrattenuta relazione: fino al rispetto scrupoloso per ogni minimo impegno contratto, fino al rifiuto degli intruppamenti omologanti in cui il noi deve di necessità prevalere sull’io, fino al disprezzo per l’eccentricità pianificata e fasulla degli snob.
Il suo autentico anticonformismo mentale, istintivo e intellettualmente protetto, era l’elemento-base affratellante rispetto ai «senza regole» da lui studiati e valorizzati, ai davvero disposti a tutto sui cammini della ricerca artistica e della conoscenza. Con loro Baldacci obbediva ad altre regole, ineludibili nella loro intima portata identificativa, secondo un atteggiamento che è dato riscontrare in tutto il suo vasto lavoro letterario fattosi opera, prezioso messaggio aperto, e insieme esistenza.
La sua stessa indimenticabile casa, per quanto tappezzata di cultura e gremita fino all’inverosimile di arte, era la «tana». I «feticci», le sue collezionate maschere di art nègre di più difficile lettura e apprezzamento da parte di visitatori che potevano magari capire benissimo Régnier o Leopardi, non lo spaventavano; un gatto diventato familiare meritava nome memorabile, umane attenzioni e lacrime di congedo, all’insegna di un umanesimo altro insofferente di ideologie risolutive, gerarchie e primati.
Così Luigi Baldacci è stato e resta un grande: nella sua «vita scritta», ben oltre quei compleanni della morte che tanto e tanto ambiguamente ci attraggono.
Marco Marchi
Palazzeschi, oggi un sorriso difficile
Ogni tanto si presenta un'occasione per tornare a parlare di Palazzeschi, ma l'eco intorno non è più quella di una volta. L'eclissi della neoavanguardia, che ne aveva assunto il rilancio, ha coinvolto anche lui. Quando ci lasciò, quasi novantenne, nel '74, era un patriarca. Oggi se ne va con quei morti che camminano in fretta. Calvino ha posto fine alla querelle se la letteratura del Novecento dovesse esser letta in chiave avanguardistica o secondo la stabilità aurea degli anni Trenta. "Ei si nomò...", e la storia del secolo disparve in un soffio. La stessa distinzione tra il Palazzeschi iconoclasta e quello toscanamente riconciliato sembra non aver più ragion d'essere. Così, nei recenti volumi einaudiani dedicati alle Opere, che accolgono tante piccole monografie sui singoli libri che meglio rappresentano gli autori, non troviamo un saggio sul Codice di Perelà, del 1911, che tutti ormai si erano acconciati a considerare come il vero capolavoro, la più eversiva protesta di questo narratore, ma uno su Sorelle Materassi, del '34, firmato da Giuseppe Nicoletti e in se' eccellente, che peraltro impone ben diversi problemi. Una studiosa che da tempo insiste nello scavo del primo Palazzeschi è invece Adele Dei. Aveva pubblicato presso l'editrice Zara di Parma I cavalli bianchi e Lanterna, e ora è la volta di Poemi, del 1909, che recavano già l'annuncio del Codice di Perelà e motivarono l'invito di Marinetti al ventiquattrenne fiorentino a entrare nella famiglia futurista. Intanto Stefano Giovanardi ha prefato i suddetti libri poetici (Cavalli, Lanterna e Poemi) per le Edizioni Empiria (a cura di Giovanna De Angelis), insistendo sulla forte suggestione figurativa di questi testi, e Marco Marchi ha intitolato Palazzeschi e altri sondaggi (Le Lettere) un volume di scritti critici dove, da Perelà alle Materassi, al Doge, protagonista è la prosa, sia in chiave filologica sia nell'indagine dei significati: per arrivare a una lettura delle Materassi del tutto innovatrice che, sotto un'apparenza piana e rettificata, rivela un magma oscuro di desideri e di proibizioni, d'impudenti esibizioni e di travestimenti, sì da rimettere in discussione il giudizio di Vittorini che, sul Bargello, rimproverava all'autore di avere scritto "un romanzo quant' altri mai romanzo". Che non era un giudizio sbagliato, bensì privo di quella psicologia ora riportata in luce. Sono motivi che circolano anche nelle fittissime note della Dei. Che significa specchio, che significa finestra? E spesso è chiamato a rispondere Palazzeschi medesimo: "Avevo due anni. Due anni e un amore già: la finestra... Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi... L'aria, la luce, il mondo, la libertà, la vita?" (Il piacere della memoria). Una trama di simboli che scorre davanti ai nostri occhi come i dipinti di una galleria: così il poeta intitolò una sezione di Poemi; e basti un esempio a chiarire il concetto: "Un prato quadrato, / cento altissimi cipressi per lato. / Nel mezzo (nessuno sa / in quale anno sia nato) / c'è un grandissimo salice bianco". Rispetto al livello di un Pascoli la semplificazione è paurosa. La valenza simbolica non nasce mai dalla parola ma dall'immagine: quasi preferiamo il Palazzeschi che si confessa (alla maniera di Arlecchino) nel Principe scomparso: "Era col suo cane bianco? / Era solo. / E dove lo vedeste? / In tutti quei luoghi / dov'esser si può, / impunemente infelici...", oppure quello che s'inventa una serie di nomi buffi di donne buffe, nomi ritratto, come sarà nel Codice. Ma nel passo appena citato c'è una virgola dopo si può, che veramente è di troppo. In seguito sarà sostituita da tre puntini di sospensione, a rendere più ammiccante la parodia, ma intanto ci rivela la scarsa dimestichezza dello scrittore coi propri strumenti. Il Marchi ci ha fornito dovizia di esempi in un saggio sulle correzioni del Codice, dove emerge che l'autore pur cercando la normalità grammaticale, non la raggiunge mai; e forse sarebbe il caso di chiedersi se questa assenza di attrezzatura retorica non abbia contribuito alla flessione di fortuna cui si accennava in un tempo, qual è il nostro, di nuova sofisticazione. Come potrebbe Palazzeschi interloquire tra Gadda e Calvino? Che cosa avrebbe da offrire ai critici e ai lettori che in costoro hanno placato ogni sete di modernità? Eppure ci ostiniamo a credere che l'autore di Chi sono?, Rio Bo, Habel Nassab, La fontana malata (titoli tutti appartenenti a Poemi), che già offriva a Marinetti gli elementi per impiantare l'apoteosi del teatro di Varietà (La fontana malata si sarebbe prestata a perfezione per una lettura di Petrolini), ci abbia tramandato di sé un'immagine non sostituibile. La passeggiata, più tardi, tutta fatta di reperti di linguaggio pubblicitario, sarà la più bella poesia dell'avanguardia (come Il codice il più bel romanzo), mentre sui tempi lunghi durerà fino a un racconto degli anni estremi, Stefanino, il gioco a nascondino con la vita (dichiararsi e negarsi) condotto con una leggerezza pari alla pervicacia. Ma a ripensarci bene, con gli scrittori comici che sono oggi in circolazione, come potrebbe far ridere Palazzeschi?
Luigi Baldacci
(“Corriere della Sera”, 16 luglio 1996)

Rileggendo “La barca” di Mario Luzi
Un deciso movimento di risalita, un “ricominciamento”. Luzi, l’“estremo
principiante” qui al principio. Con le poesie de La barca Luzi ventunenne debutta nel
1935. La sua disposizione di poeta esordiente verso la capacità evocativa della parola
subito s’intreccia, stante il titolo, con la fiducia nella rappresentazione visiva di
quanto costituisce per lui l’oggetto del fare poetico: la vita stessa considerata nel suo
incessante fluire, nel suo dinamico e fatale trascorrere.
Dalla barca di Luzi “si vede il mondo”, si scopre la vita, da soli e in compagnia di
amici, di amici-poeti come ai tempi di Dante e dello Stilnovo. “All’editore Guanda
non piaceva il titolo – scriveva l’autore a Piero Bigongiari –, ma io ho insistito su
quello. È significativo e appartiene ad un oggetto reale senza essere fraseologico e
troppo apertamente logico come lo sono anche i migliori e più concreti di questi
ultimi anni: Realtà vince il sogno, Sentimento del tempo”.
L’opzione è dichiaratamente rivolta – tra referenti betocchiani e ungarettiani – ad un
lirismo non per simboli ma per segni concreti, ad un linguaggio che già aspira a farsi,
precocemente, linguaggio della metamorfosi.
L’antitesi individuo-cosmo, la grande problematica consegnata dalla modernità al
Novecento, è da Luzi rimessa in gioco e rifusa nella poetica della “fisica perfetta”. La
“barca di salvezza” di montaliana memoria sarà il luogo deputato di questa prima
sintesi di esperienza ed esistenza, la dimensione purgatoriale da cui, scampati al
naufragio – e Allegria di naufragi era stato il titolo dell’Allegria di Ungaretti –,
tentare la fluviale risalita “dalle foci alle sorgenti”, il ricongiungimento a un unico
“sospiro”.
Il poeta “principiante” avverte l’importanza delle voci allora dominanti, ma va per la
sua strada, suscitando semmai, nell’ammirazione per Betocchi, il primigenio
Rimbaud e Mauriac, la dimensione di un rustico e pauperistico cattolicesimo di
provincia che favorisce l’atto poetico: atto poetico – come puntualmente rilevava
Giorgio Caproni nel recensire il libro – da ascrivere a un giovane uomo di fede.
“Di questa pace interiore – notava Caproni –, cui solo un compiuto credente può
giungere, è naturale riflesso anche la pacificazione dei modi esteriori"; talché, in una
prospettiva elegiaca ma umanamente sensibilizzata, già si potevano rintracciare “due
distinti ma non contrastanti motivi: un radicato affetto per le cose, e il dolore che, con
la coscienza della lor vanità, esse arrecano all’anima”.
Le liriche della Barca, come avrebbe d’altronde chiarito in seguito Luzi stesso, “non
ebbero all’origine alcunché di sperimentale o di scolastico, ma segnarono in termini
persino troppo scoperti l’emozione di un primo contatto con la vita”.
Un universo sentimentale di provenienza biografica sigla così, alla luce dell’arte
senese e delle sue mirabili quintessenze, connotati e figure: madri, fanciulli “con lo
sguardo profondo”, fanciulle “con le fronti pensose”, fragili donne e trepidi
adolescenti, tutto un popolo di creature fissate in gesti e situazioni elementari,
partecipi presenze di quella “naturale volontà” che è per Luzi segno cristiano e
tellurico del mutamento.
Una poetica è in atto, densa di sviluppi e fedeltà a lungo corso. Esemplificano, e ora
più che mai commuovono, i versi iniziali di Alla primavera: “In allegrezza le foglie
cantano la loro resurrezione, / nel cuore della natura trema la dolce emozione / di
risalire dentro i tronchi morti”.
Marco Marchi
Alla vita
Amici ci aspetta una barca e dondola
nella luce ove il cielo s’inarca
e tocca il mare, volano creature pazze ad amare
il viso d’Iddio caldo di speranza
in alto in basso cercando
affetto in ogni occulta distanza
e piangono: noi siamo in terra
ma ci potremo un giorno librare
esilmente piegare sul seno divino
come rose dai muri nelle strade odorose
sul bimbo che le chiede senza voce.
Amici dalla barca si vede il mondo
e in lui una verità che procede
intrepida, un sospiro profondo
dalle foci alle sorgenti;
la Madonna dagli occhi trasparenti
scende adagio incontro ai morenti,
raccoglie il cumulo della vita, i dolori
le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.
Le ragazze alla finestra annerita
con lo sguardo verso i monti
non sanno finire d’aspettare l’avvenire.
Nelle stanze la voce materna
senza origine, senza profondità s’alterna
col silenzio della terra, è bella
e tutto par nato da quella.
Mario Luzi
(da La barca, 1935)

Mario Luzi, Adriana Pincherle.
Il canto diviso di David Maria Turoldo
Preme fortemente nella produzione poetica di David Maria Turoldo quella sorta di
sostanziale incommensurabilità di Dio rispetto all’uomo cui con affascinante
pertinenza Karl Rahner si riferisce nei suoi scritti. E proprio questa enigmaticità,
anzi, a produrre in Turoldo un canto di ispirazione religiosa inquieto e diviso, aspro e
non di rado dilaniato al suo interno, foriero di scandali e belligeranze non meno che
di umana e creaturale compassione. La «cella solitaria» del poeta friulano presto in
effetti si apre, il viaggio in una stanza presto si avvia a prevedere – oltre le seduzioni
di un’«oscura luce» e la «sicura chiarità» di un «piccolo nido» – un villaggio
universale della crudeltà e dell’ingiustizia, del consumismo e della guerra,
dell’alienazione e della ferocia umana.
È un amore di tempra reboriana che infiamma altro amore, che, per accettazione e per
protesta, amando e lasciandosi contagiare dall’amore, trova là il suo inveramento, che
si completa facendosi presenza tra le cose in balìa del precario, instabili e già
trascoloranti: «Mia natura è di essere / presente: amare / la realtà che sento: toccare, /
divenire queste morenti cose / salvarle nel mio gesto / di pietà. Mia tristissima / gioia
di questi possedimenti / sempre dispersi: di queste / inesistenze: amore di case / che
debbo lasciare; di questa / mia perita città».
Così dicono i versi di Mia natura, nel giocare rispetto all’«Ego sum qui sum»
dell’Esodo (altrove liricamente affrontato per via di citazione) sul valore
verbale/copulativo di un «essere» ambiguamente a fine verso, incentivando – oltre
l’espressività dell’enjambement –l’ossimoro e l’antitesi, ricorrendo al deittico
ungarettiano della concretezza, della desolazione carsica e dell’essenzialità bellica,
chiamato a dare risalto all’hic et nunc, a ritrovare tra i confini della contraddizione i
luoghi operativi della presenza, esistenziali, religiosi e poetici. Una «perita città» che,
soprattutto nella lirica turoldiana di mezzo (quella degli anni Settanta, specialmente,
o come espressamente periodizza un sottotitolo dopo il 1968) si specificherà in
accezione politica del canto, in annessione di dati della cronaca in rapporto a
un’esigenza modificatoria e, prima, a un disegno storico superiore, di continuo
interrogato, posto senza tergiversazioni e infingimenti di fronte al negativo, messo,
assieme all’uomo, alla prova.
I due grandi movimenti della poesia di Turoldo, le sue tensioni fondamentali e
calamitanti, si profilano: la riaffermazione della concordia e la lode delle meraviglie
che nel mondo in cui Cristo si è calato si rinnovano, e insieme la contestazione delle
intollerabili permanenze dell’antico, della disarmonia non sanata, degli intralci alla
reintegrazione del vitale, che è come dire la problematica adesione al nuovo
intervenuto, a una riconciliazione consentita e promessa ma che non annulla ipso
facto, mimeticamente rispetto alle necessità espiatorie di un umanissimo Christus
patiens inconsapevole, anteriore alla vittoria e al trionfo (si veda ad esempio, a
suggello della raccolta del 1987 Il grande Male, la suite narrativa La notte del Signore), il dolore e la morte.
«In verità io ti dico che domani...», secondo alcune delle ultime parole dalla Croce.
David si fa Giobbe, la poesia di Turoldo si conforma – nel ricercare ciò che Salvatore
Natoli ha definito nell’Esperienza del dolore l’«abbandonarsi a una potenza
consolatrice» – alle possibilità offerte dalla salmistica, all’ascolto stilistico di una
gamma di generi, inclusiva – nel parlare a Dio e di Dio – della realtà peritura e
sofferente di un mondo costretto ancora a scontare l’inesplicabile, il tragicamente
difficile da capire ed accogliere: la distanza da quel Dio. La poesia per suo conto
conforta e interroga, ritrova certezze e denuncia, inneggia forte del suo costitutivo
«non sapere» di atto incoercibile e ambiguo e intona a nome di tutto il mondo il
proprio compianto.
È così che l’incontro con Leopardi, con un Leopardi sub specie di «anima» ritrovata,
«condanna assoluta, voce senza scampo, così disperata e lucida», intenta oltre le
apparenze a indagare il mistero, appare inevitabile (A Leopardi, anima mia, in Il sesto
Angelo). È così che altrettanto ineludibile e impellente, sotto il segno di un’analoga
incandescenza, si rivela l’incontro con la poesia italiana contemporanea, a partire da
quella del secondo dopoguerra con il realismo e il dibattito sul realismo, con le letture
(talvolta di clima) di poeti americani e sudamericani, con gli ampliamenti tematici e
linguistici che hanno investito la lirica di tradizione ermetica, fino, in Turoldo, ai
testimoniati dubbi bloccanti ed autodistruttivi innescati dalla presunta
disappartenenza – nonostante l’anomalia di posizione rivendicata – a una vicenda
artistica comune e in questi termini, secondo questi diagrammi e secondo queste
verifiche storiografiche giunte all’odierno, dotata di plausibilità.
Turoldo poeta scrive allora testi come Requiem per il Vietnam, Salmodia per il Cile,
Ballata per i campesinos della Bolivia!: testi di carattere politico-sociale e
ideologico-militante confluiti per la maggior parte nel Sesto Angelo e soprattutto in
Fine dell’uomo? (libri ambedue del 1976), e drasticamente penalizzati – secondo gli
opportuni rilievi in chiave variantistica forniti da Giorgio Luzzi – dalla rizzoliana
silloge del 1990 O sensi miei..., la quale al contrario, antologizzando, ripropone
integralmente i primi quattro libri, moderatamente sfoltisce e calibra Il grande Male e ristampa senza ripensamenti aggiornanti il recente Nel segno del Tau.
Marco Marchi
Ma tu sempre
Tu sempre m’intendi
pur se mormoro o grido:
tu l’Ineffabile
perfino Tenebra luminosa!…
Così varcherò l’ultima soglia
l’anima danzando…
Salmo 8
Come splende, Signore Dio nostro
il tuo nome su tutta la terra.
Lasciami anche dalla tomba un pertugio,
che io possa ancora vedere
il sole che sorge
una nuvola d’oro,
Espero che riluce la sera
in un limpido cielo.
E mai abbia fine questa Coscienza
che i cieli immensi comprende
e più riflesso di te
che lo orni di divino splendore;
senza, non c’è voce che ti canti.
Preghiera
Svegliati, mia arpa,
che voglio destare l'aurora:
cantare i silenzi dell'alba
chiamare le genti sulle porte,
e salutare il giorno:
e dare speranza agli umili
e dire insieme la preghiera
del pane che basti per oggi:
allora anche i poveri ne avranno d'avanzo.
Amen.
David MariaTuroldo
(da Ultime poesie. 1991-1992)

Montale, o della disarmonia
Montale muove nel suo scrivere versi dal non sentirsi in sintonia con la vita, con il mondo e con se stesso. La sua poesia del disaccordo, dell’interrogazione, dell’insoddisfazione e dell'incertezza, si accorda bene a quel più generale quadro della
letteratura italiana del primo Novecento che sul piano della narrativa presenta i grandi nomi di Svevo, Pirandello e
Tozzi. Non sarà un caso che Montale sia stato uno dei responsabili della tardiva scoperta del grande Italo
Svevo, e questo probabilmente sulla base di una concezione dell’esistenza che, nonostante le diverse età e le diverse esperienze maturate, i due scrittori avevano in comune.
Giacomo Debenedetti ha parlato, a proposito di Svevo, Tozzi e Pirandello, di «romanzo interrogativo»: romanzo nuovo, innovativamente avanzato e proiettato al futuro, in quanto fuori dalle facili forme di presunta
esplicabilità sperimentate ed autorizzate dalla narrativa precedente. C’è una crisi in atto del
naturalismo: una crisi che vede decadere la possibilità di spiegare il mondo secondo le tradizionali categorie di causa e di effetto e vede invece prepotentemente affacciarsi un
interrogativo: la letteratura della crisi del naturalismo è una letteratura modernamente alla ricerca del
senso. Mentre gli scrittori di tipo naturalista e verista scrivevano perché sapevano spiegare la realtà (e lo dimostravano concretamente, con il ricorso teoricamente sostenuto ed
efficiente alle risultanze scientifiche del positivismo), i narratori nuovi del Novecento scrivono perché non sanno più
spiegare il reale.
Ecco che nella pagina di questi scrittori si insinua un’incertezza, un’instabilità di prospettive, una difficoltà di
movimento. L’ambito della poesia coeva non è molto distante da queste intervenute difficoltà e da queste nuove esigenze profilatesi. Leggendo le poesie del primo Ungaretti e quelle del primo Montale ci accorgiamo che anche nella produzione poetica di questi autori domina
un’inquietudine: la realtà non offre più quelle certezze di cui si faceva portavoce nell’ottica naturalista ottocentesca. E l’insicurezza investe anche l’interiorità dell’uomo.
Gli scrittori citati portano alla ribalta i temi alternativi di una ricerca psicologica che culmineranno nella scoperta
dell’inconscio e della psicoanalisi di Freud, che dimostrano che l’uomo è qualcosa di molto più complesso e misterioso di quanto si fosse immaginato fino a quell’epoca.
La poesia di Montale fin dagli Ossi di seppia
è la poesia della disarmonia, della dicibilità al negativo dell’esistere, a partire dalla definibilità per via negativa
della poesia stessa. Montale conduce un discorso molto rigoroso e molto personale in cui coinvolge tutte le
risorse storiograficamente testabili appannaggio del linguaggio poetico: tutte le risorse del senso e tutte le risorse del suono che una storia della poesia italiana ha condotto
fin lì, già differenziandosi sostanzialmente in questo bilanciamento dalla strada coeva di Giuseppe
Ungaretti. Poco importano, a ben vedere, i poco cordiali rapporti biografici intercorsi tra i due poeti, che
non si sono mai troppo amati perché concorrenziali nell’immagine del più grande poeta italiano del Novecento. Importa invece notare come effettivamente, leggendo i testi dei due
poeti a confronto, le vie si divarichino.
E si divaricano sensibilmente: fin dal modo di esordire sulla scena letteraria. Ungaretti debutta poco prima di Montale e
lega il suo nome ad Allegria di naufragi, del
1919, che a sua volta sussume i componimenti del precedente Porto sepolto, editi soltanto in 80 copie nel 1916. Montale sei anni dopo, nel 1925, pubblica la prima edizione di Ossi di seppia. Le strade si presentano subito diverse, nel senso
che Ungaretti pensa con fiducia di tipo avanguardistico di poter sillabare la lingua italiana dando espressione al suo nuovo modo di porsi in contatto con la realtà: la possibilità intravista dal poeta di poter fare a meno in qualche modo di una tradizione della poesia italiana giunta fino agli anni della
prima guerra mondiale, e la possibilità alternativa, in una situazione dolorosamente eccezionale, tragicamente straordinaria come la guerra, di ricominciare a «pronunciare il
mondo». Una fiducia forse resa possibile o almeno incrementata in Ungaretti dal fatto di provenire da Alessandria d’Egitto, di essere uno «spatriato» geograficamente ed autobiograficamente accertabile, in qualche modo sufficientemente distanziato da una vicenda
letteraria secolare che invece un poeta come Montale ha sempre sentito più vicina, anche nei suoi studi e nelle sue primissime pratiche linguistiche, nel corso stesso della sua
formazione culturale anteriore al debutto poetico.
In altri termini Montale oppone alla scelta rivoluzionaria, radicalmente e potentemente rivoluzionaria di un Ungaretti alla
ricerca di un paese e di parole innocenti, un libro come Ossi di seppia: un libro che un critico, Pier Vincenzo Mengaldo, ha persuasivamente definito documento di «conservatorismo linguistico»,
intendendo dire con questo un libro agli antipodi con la poesia di cui si fa portavoce Ungaretti: una poesia, quella
degli Ossi, che mutua il suo linguaggio dalla
tradizione immediatamente precedente al suo atto linguistico, che intrattiene con quella tradizione linguistica forti legami. Potremmo dire – semplificando e quasi ignorando
le protostoriche poesie di genere palazzeschiano-lacerbiano, avanguardistico-futuristiche e crepuscolari che Ungaretti aveva
scritto e che di Ungaretti si conservano – che il primo Ungaretti fa sostanzialmente a meno di una storia della poesia italiana giunta al 1919, epoca di Allegria di naufragi. Quello stesso Ungaretti si dimostra pronto poi, con Sentimento del Tempo,
a rivedere questa sua posizione. Eugenio Montale, nello scrivere le poesie che confluiranno nel 1925 in
Ossi di seppia, dichiara al contrario la sua derivazione, la sua
dipendenza di tipo storico-linguistico dalla poesia che lo ha immediatamente preceduto, confidando, in vista dell’originalità, di una relazione di conoscenza e superamento da intrattenere con i
modelli preesistenti.
Sta di fatto che senza la sperimentazione linguistica e formale di D’Annunzio (basti pensare a un testo di assoluto rilievo
come Alcyone) gli Ossi di seppia non sarebbero stati quelli che oggi noi leggiamo e valutiamo in
tutta la loro importanza storiografica. Il linguaggio che Montale adotta nell’esprimersi nel suo primo libro è fortemente intriso di lezioni soprattutto dannunziane, ma anche
pascoliane e carducciane; di un linguaggio cioè che attraverso la possibilità di cogliere una storia della lingua della poesia italiana ad altezza primonovecentesca sussume anche la tradizione
più antica. Potremmo dire che Ungaretti è fiducioso in una sorta di solitudine del poeta: il poeta che in qualche modo da
solo tenta la voce della poesia, tenta la voce di suoni e di significati della poesia. Montale, al contrario, per esprimere la sua originalità ed affermarla compiutamente, sente il bisogno di
riferirsi ad una lingua poetica formalmente concresciuta attraverso i contributi di molti, giunta a lui con il suo forte e talvolta gravoso bagaglio di scelte, di responsabilità, di strumenti
espressivi già messi a punto e sperimentati, di possibilità culturali ed espressive sondate.
Dobbiamo dire allora che Ossi di seppia
è un libro dannunziano? No: Ossi di seppia
è il libro forse più profondamente antidannunziano che esista agli inizi del Novecento, proprio perché Montale utilizza una
sorta di continuità linguistica garantita dai suoi precedenti per effettuare il suo attraversamento critico, che lo porta ideologicamente al di là del conservatorismo linguistico di un libro
come Ossi di seppia, che non a caso ad Ungaretti sembrava un libro attardato (per lui era il libro di un «floreale» non
dotato della modernità dirompente che invece egli rivendicava con sicurezza alla propria poesia). Montale, poeta
«floreale», apparentemente dannunziano e di clima, frutto di una tradizione epigonicamente seguita, in realtà mediante l’attraversamento critico di quel tipo di risorse fa una sua
proposta estremamente originale, affidandosi ad una continuità di tipo linguistico che si risolve in realtà in una potente
discontinuità di tipo ideologico. Un'originalità cui oggi tutti siamo disposti a riconoscere lo straordinario valore.
Marco Marchi
I limoni
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall'azzurro:
più chiaro si ascolta il susurro
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest'odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l'odore dei limoni.
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s'abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità
Lo sguardo fruga d'intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità
Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta
il tedio dell'inverno sulle case,
la luce si fa avara - amara l'anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità.
Eugenio Montale
(da "Ossi di seppia", 1925)

Palazzeschi e il melodramma
Recita con arguzia una poesia del tardo
Palazzeschi di Via delle cento stelle intitolata Il melodramma: «Non v’è dubbio che lo spirito
italiano / del nostro ultimo tempo / si sia temprato al fuoco del melodramma. / Il melodramma è l’esponente / di questa
nostra ormai invecchiata / ma ancora resistente civiltà. / Accettata tale premessa / resta solo da domandarci / se l’italiano / melodrammatico per natura / abbia creato il
melodramma / o il melodramma abbia creato lui / melodrammatico di conseguenza».
Sta di fatto che fin da giovane, con assoluta precocità, Aldo Palazzeschi promuove il melodramma a componente visibile dei
suoi avanguardistici scherzi di gioventù e, insieme, della sua cultura di autore formidabile: di scrittore illetterato e geniale, che anche nella simpatia per la «musica delle
grandi passioni» e addirittura nella proclamata predilezione per due opere messa in bocca al suo io letterario diviso (il maschile «lavativo» poeta e la femminile «virile» Contessa Maria
dell'indimenticabile Interrogatorio) si ribadisce «incendiario», e sia pure, lasciando trapelare l’altra faccia «grigia» anzichè «rossa», malinconica e crepuscolare della sua personalità,
un «povero incendiario da poesia».
In un romanzo così trasgressivo ed implicante da restare miseramente impubblicato nel cassetto
come Interrogatorio della Contessa Maria il verdiano Trovatore (librettisticamente citato nell’emblematica aria di Manrico Di quella pira…) e la belliniana Norma subito si impongono come le opere predilette: si impongono in abbinamento e di necessità, perché ambedue opere ignifere, incendiarie, conclusivamente affidate, nell’ambito dei loro diversissimi intrecci conflittual-passionali sublimati in musica, all’ardore dell'eros e
alla risoluzione catartica del rogo, del fuoco che nel contempo distrugge e purifica.
Norma e Trovatore, del resto, avevano già fatto la loro certificabile apparizione in chiave ludica di ribaltamento e di paradosso in una «Spazzatura» apparsa sulla rivista del futurismo fiorentino «Lacerba» il 21 febbraio del 1915: «Spazzatura» in seguito rimasta, ci si passi il gioco di parole, irraccolta, consistente in davvero provocatori, sintetici e scandalosissimi Melodrammi produttori di riso, la cui oscena gamma di riferimento per via di
prelievi testuali a doppio senso svaria – oltre molto Verdi, oltre Bellini e Mascagni – dal Donizetti di Lucia e dell’Elisir d’amore al Puccini di Bohème, dal Ponchielli di Gioconda al Catalani di Loreley, dal rossiniano Guglielmo Tell al Lohengrin di Wagner secondo Cescatti, fino al Paisiello
di Nina ossia La pazza per amore, con la sua nenia Il mio ben
quando verrà che avrebbe potuto partecipare di diritto pure alla parte finale del testo, al suo pirotecnico apice umoristico su base vocabolaristica da equivoci e fraintesi con
relativi commenti d'autore.
L’immoralismo di Palazzeschi, nello scritto di «Lacerba», trionfa. Ma a noi qui interessa piuttosto
suggerire come la poetica di Palazzeschi fin da allora avesse già previsto con ampiezza il differito dei traslati e il falso, l’innaturale e il teatrale, e in primo
luogo fornire proprio attraverso il melodramma da Palazzeschi frequentatissimo, tra parodia e condivisione, un esempio
di «scriver cantando».
In esso è efficiente (siamo nel 1909) La Bohème di Puccini (anno di debutto dell'opera 1896, successo strepitoso immediato e protrattosi, come tutti sanno, fino ai
nostri giorni). Pensiamo al celebre Chi sono? posto dall'autore ad apertura di Poemi e in seguito confermato in altre sillogi delle sue poesie in tale
posizione privilegiata: una canonica lirica-autoritratto culminante tramite negazioni ed esclusioni nel suggestivo endecasillabo definitorio che recita
«Il saltimbanco dell'anima mia»; una lirica tributaria nei confronti dell’atto I della pucciniana Bohème.
«Chi son? – dunque, canta Rodolfo, muovendosi al buio di una fredda soffitta parigina e già come Palazzeschi divertendosi –
Sono un poeta. / Che cosa faccio? Scrivo». Rodolfo fornisce così a un altro poeta in vena di autointerrogazioni («Chi sono?») e in cerca di definizioni di sé mediante la «penna dell’anima» il riferimento scrittorio e perfino lo specifico vocabolo «anima» («l’anima ho milionaria»).
Spetterà invece alla replica dell'importuna, sottilmente maliziosa più che sventata vicina Mimì (Sì. Mi chiamano Mimì), per suo conto artistica artigiana del falso, autorizzare un
gioco di sensi al negativo (fiori ricamati, artefatti, i suoi, che «non hanno odore», per un Palazzeschi che
per di più qui scrive, echeggiando, «Non ha che un colore») e contribuire soprattutto
all’allestimento della sequenza rimica portante del componimento: mia alternativamente rimante con follìa, malinconìa, nostalgìa. A partire dal suo stesso nome anagrafico
dichiarato, Lucia, che nel testo
librettistico dell'aria rima, sempre in -ia,
ripetutamente, con mia, malìa e poesia.
Marco Marchi
Chi sono?
Chi sono?
Son forse un poeta?
No, certo.
Non scrive che una parola, ben strana,
la penna dell'anima mia:
«follìa».
Son dunque un pittore?
Neanche.
Non à che un colore
la tavolozza dell'anima mia:
«malinconia».
Un musico, allora?
Nemmeno.
Non c'è che una nota
nella tastiera dell'anima mia:
«nostalgia».
Son dunque... che cosa?
Io metto una lente
davanti al mio cuore
per farlo vedere alla gente.
Chi sono?
Il saltimbanco dell'anima mia.
Aldo Palazzeschi
(da Poemi, 1909)

Zanzotto fisico e metafisico
Notava Montale in un suo memorabile intervento dedicato a La Beltà, che in Andrea Zanzotto si esprime “il tragico dissidio tra quella che i
cristiani dicono anima e ciò che gli scienziati dicono psiche”. Indicando questo nodo, Eugenio Montale coglieva nel segno circa attualità e futuri sviluppi dell’opera del poeta,
illuminandone tecniche e strategie messe in atto nel rispondere per via scrittoria a tale rilevazione, a tale insopito, rinascente bisogno di accertamento: “Zanzotto non descrive, circoscrive, avvolge, prende, poi lascia”.
È così, in effetti, che Zanzotto si muove tra i materiali fonico-immaginativi che affollano
il suo formidabile e interminabile laboratorio di poeta novecentesco fatto di sostanze semantiche e presemantiche, combinazioni grammaticali e pregrammaticali, soluzioni
linguistiche e prelinguistiche, costantemente alla ricerca della pietra filosofale che gli permetta di riprodurre in versi
la fabula straniante individualissima che chi
scrive sta vivendo. Il poeta perviene in tal modo – cito ancora da Montale – ad una “poesia inventariale che
suggestiona potentemente e agisce come una droga sull’intelletto giudicante del lettore”, bilanciandosi tra individuazione di se stesso e relazionalità con il reale mediante una
sorta di “mobilità insieme fisica e metafisica”.
Una “mobilità insieme fisica e metafisica”. Sta di fatto che, nel leggere
l’alta, storicamente autorizzata e paradigmatica poesia di Zanzotto viene un momento in cui l’effetto dello stupefacente
poetico-espressivo raggiunto e comunicato, disposto anche in chi lo recepisce a tutte le possibili arditezze acrobatiche per via di interferenze e sprofondi semantici, nessi analogici e
simultaneità, cessa, si annulla, e la mente, sgombra di lusinghe ammiccanti e fascinazioni, riacquista di colpo piene facoltà coscienziali: facoltà accresciute, potenziate
dall’esperienza della quale è stato al centro, sperimentando di persona, all’apice della fruizione artistica consentita, l’ontologica compresenza dei due livelli.
In altri termini, quando le parole di Zanzotto “lasciano”, è inevitabile il subentro o meglio
il valorizzato ritrovamento del giudizio, dell’istanza razionalistica alla chiarificazione critica di ciò che la visione trasfigurante, imponendosi magicamente con i suoi tratti e
i suoi specifici attributi fascinatori all’attenzione, accantonava o pretendeva per un momento almeno di potere omettere.
Un analogo, quintessenziale e sincretistico percorso tra emozione e riflessione, Es e coscienza, che ci riconduce in campo storiografico-artistico a
quell'ineludibile bivio novecentesco tra l’ordine e la pulsione e nell'universo espressivo del poeta ai suoi
magnifici cortociruiti della scrittura in cui tout se
tient.
Marco Marchi
Notificazione di presenza sui Colli Euganei
Se la fede, la calma d’uno sguardo
come un nimbo, se spazi di serene
ore domando, mentre qui m’attardo
sul crinale che i passi miei sostiene,
se deprecando vado le catene
e il sortilegio annoso e il filtro e il dardo
onde per entro le più occulte vene
in opposti tormenti agghiaccio et ardo,
i vostri intimi fuochi e l’acque folli
di fervori e di geli avviso, o colli
in sì gran parte specchi a me conformi.
Ah, domata qual voi l’agra natura,
pari alla vostra il ciel mi dia ventura
e in armonie pur io possa compormi.
Andrea Zanzotto
(da IX Ecloghe, Mondadori 1962)

Sandro Penna e il pastorello
Un poeta novecentesco e il melodramma... Il popolare melodramma, con la sua parola, la sua musica e il suo gesto compattati in un universo figurato memorabile, eccessivo e profondo, di modalità comportamentistiche emblematiche, valori ed affetti, è giocoforza che culturalmente (storiograficamente) collabori, si insinui e si confonda, partecipando dell’immaginazione, rinascendo sub specie artistica in altre forme, contribuendo, per progetto o per involontario parlare di linguaggi che s'intersecano, al completamento o alla sostituzione della vita cui chi scrive o ad ogni modo pratica l’arte, in cerca di libertà, obbedisce.
Chi direbbe, ad esempio, nel non troppo culturalisticamente sospettabile Sandro Penna (l’autore tuttavia, su esibita suggestione verdiana da Traviata, di Croce e delizia, componimento singolo e raccolta) di poter rinvenire un’esemplificazione probatoria di questo tipo, leggendo una poesia di Stranezze? Dice il testo:
Voleva raccontare una sua storia
il pastorello, ma il sonno lo prese.
I rauchi treni implorano alle stelle
e riaccendono i volti nel mio cuore.
Il lessico, la semantica, la metrica, la sintassi del componimento si frangono e subito si ricompogono. Un’aria per tenore di grazia alla Ferruccio Tagliavini o alla Tito Schipa, il Lamento di Federico dell’Arlesiana di Francesco Cilea (1897, libretto di Leopoldo Monaco dal dramma di Alphonse Daudet), traspare:
È la solita storia del pastore
Il povero ragazzo voleva raccontarla, e s’addormì.
E ancora, contemplando l’Innocente e preparato dal vespertino coro di «Voci lontane» che per suo conto, anche sentimentalmente ambientando, recita «Quando la luce muor, / mesto diviene il cor!»:
C’è nel sonno l’oblio. Come l’invidio!
Anch’io vorrei dormir così,
nel sonno almen l’oblio trovar!
La pace sol cercando io vo’,
vorrei poter tutto scordar.
Pur ogni sforzo è vano… Davanti
ho sempre di lei il dolce sembiante!
Secondo esempio in Penna, ancora recuperabile nel Penna di Stranezze che un’altra volta intitola come accennavamo, in omaggio al tema unico e fagocitante dell’amore, Croce e delizia. Ecco, per via di contaminazione e di concentrazione, nel breve giro di una quartina densissima, memorie verdiane nientemeno che da Traviata, Trovatore e – in quel «Riccardo» che doppia perfettamente, proprio in posizione finale, il canto appassionato e invocante di Amelia all'ultimo atto (i melomani penseranno di sicuro a Maria Callas, con il suo indimenticabile «A' piedi tuoi m'atterro») – Ballo in maschera:
Croce e delizia
Ahi, troppo forte ardo
entro sì oscure nebbie.
E inutili i poetici
voli per dir: Riccardo.
Marco Marchi

UN APPUNTO SU LUZI E DANTE
«Tutto Dante – ha affermato con icastica efficacia Mario Luzi – è un dramma che cerca di ricomporsi in una suprema catarsi e in una raggiunta armonia». In questa prodigiosa, irresistibile attrazione, in questa coltivata e partecipata tensione è dato intravedere al lettore di Luzi che sia a conoscenza dell’intera sua opera poetica quella luce ritrovata, quel sorriso colto con Dante come un inprinting dell’esistente: un inprinting rintracciato e celebrato, grazie alla poesia, oltre l’oscuro affliggente, da selva dello smarrimento che nel Novecento e nell’incipiente Duemila si è fatto e si fa sgomento, da selva della «mortalità» e della Storia: oltre l’inferno stesso, e oltre le brucianti incarnazioni visibili dell’assurdo dei lager e delle residue speranze di umana sopravvivenza lì coltivabili, espresse proprio attraverso Dante in Se questo è un uomo di Primo Levi.
A Luzi il problema di un rapporto non solo suo, ma della poesia d’oggi tout court con la poesia di Dante si è posto chiarissimo, e non certo foriero di sole impossibilità, di intangibilità: «Forse oggi – si legge in Dante, da mito a presenza – nessun poeta può nutrire l’illusione di risalire come Dante alla sintesi e tanto meno all’armonia delle sfere che tutto presagisce e tutto contiene. Nessuna guida che abbia già chiaro per sempre il rapporto tra il particolare e il disegno di insieme gli è mandata incontro. Più facilmente un testimone di iniquità o un maestro di dubbio. Così com’è, la nostra cultura non consente di più: essa apre molte ipotesi ma non chiude nessun cerchio né indica alcuna strada come sicura. E tuttavia – continua Luzi – la necessità di una poesia che ritenti la vita nella sua legittimità primaria all’interno del mondo e della sua lacerazione, non avendolo rimosso in una condanna o nella sua indifferenza e parli con voce di chi è dentro la prova e non l’ha né rifiutata né misconosciuta, è abbastanza per giustificare ancora il poeta e ancora iscrivere il destino della poesia nel destino del mondo».
«Dentro la prova», o come altrove Luzi dirà «da dentro il patema», facendo della poesia sublime di Dante come della propria, al di là delle distanze e delle differenze, un unico «tentativo di rimettere l’uomo di fronte a se stesso in questo perverso processo di disumanizzazione che è in corso». In un diverso ma condiviso percorso in crescita, ad indirizzo ascensionale, letificante, «salutare» e rassicurante, che è venuto spostando con naturale forza inverante l’opera di Luzi oltre l’insensatezza del «dramma» e dell’«enigma» di una propria dichiarata immagine di uomo ed artista alla ricerca, già è dato ravvisare preliminarmente il graduale concrescere mitografico-immaginativo della Commedia.
Un modello impossibile da riattivare nelle sue architetture e nei suoi ordini supremi, e anche nei suoi dominati livelli di lettura (dal letterale all’allegorico, dall’analogico al morale), per via di quei compatti riconoscimenti di quella «provedenza che governa il mondo» di cui parlava Dante a Cangrande. Ma un Dante moderno pure nel dominio dell’antipoematico, dell’instabile e dell’insicuro, «del frammentario e del discorde» come Luzi dice, perseguibile anche così come esempio sommo, indirizzo, conato e aspirazione, fascino: a tal punto una protratta e sensibile inchiesta del reale come quella che anche Luzi ha affidato agli strumenti della poesia porta a Dante, a una lezione di Dante ineludibile, profondamente attiva ed implicata negli esiti raggiunti, in essi decisiva e in questi termini ravvisabile.
Marco Marchi
Stanno sopra di te
Stanno sopra di te
ariosamente
gli alberi erborando,
s’invoglia nel suo azzurro il cielo,
si sente persuasa
di sé, in sé precisa, a niente
remissiva ogni vita
antica ed incipiente,
ogni erba, ombra, volo,
ogni risorgiva.
Scande
la somma equalità del giorno
il verso del cucù.
Vivi e guardi, teste non sei
ma parte. Oh mondo, mondo.
Mario Luzi
(da Lasciami, non trattenermi)

Nell’immagine: Luzi in un ritratto di Pietro Paolo Tarasco
Alfonso Gatto oltre l’ermetismo
Un «giardino incantato», dirà in un importante incontro di studio Alfonso
Gatto, riferendosi all’ermetismo e alla sua testimoniabile
partecipazione a quelle importanti vicende della poesia italiana del Novecento. Ma fuori da quel giardino e da quegli incanti, da quell’«erba» magnificamente difesa dalle accuse in una lirica che vale da sola mille saggi e mille dibattiti (è la nota
Fummo l’erba), quali le musiche cui accordarsi, quali gli
accordi e prima ancora gli «sgorghi nel canto» (Inverno) da cui farsi tentare, da tentare?
In realtà l’inconsapevole mano rilkiana che sa di scrivere qualcosa
d’ignoto, qualcosa che il poeta sostanzialmente non è in grado di capire, non rinuncia nel melico Gatto – un poeta costantemente tentato dalla musica, abitato da essa –, a forme di coscienza inquadranti, a garanzie
di qualità che implicano in lui, fin da altezze cronologiche antiche, da avvio di percorso e con tutta probabilità da input stesso del processo,
una comunanza di destino allargata, perfino una pregressa «storia delle vittime» da rinvenire all’insegna della morte e delle possibilità di auscultazione del
silenzio, in un’amorosa possibilità di interscambio e di recupero del canto ad essa connessa.
A questa storia comune, a questa sorte condivisa, drammaticamente umana e
drammaticamente deperibile, il poeta immediatamente si annette, orientando il dono ricevuto per spartirlo, a patto di deludere quanti vorrebbero da lui e dalla sua poesia altri
indirizzi, altri rigori, altri generi di coinvolgimento: altra, Gatto avrebbe detto, «cultura». E qui si siglano, oltre le divergenze da una linea montaliano-eliotiana, quelle da un Sinisgalli o da un Bodini, come pure da altri rappresentanti illustri, diciamo pure «senza sud», dell’ermetismo fiorentino, da Luzi a Bigongiari, a Parronchi.
Gatto, «morto ai paesi», non teme insomma di ritrovarsi festoso «bambino
tutto suono». Quante sere, e non solo sere crepuscolari, nella poesia di Gatto! Un’ora topica, incerta, di trapasso, secondo le ricorrenze segnalate dalla critica, a partire da
Foscolo e da Leopardi. È così che in Alfonso Gatto la sera aggetta tra prima e dopo, memoria e presentimento, sulla notte, la morte (come nella bipartizione
perfetta di un verso di Vivi), come se la poesia e i suoi rivelanti e salvifici recuperi musicali dal silenzio, le sue
musiche da resurrezione del vivente strappate all’invisibile potessero finalmente
squarciare quel nero manto meridionale e universale che incombe, ridare colore e
corporeità a vite troncate, condannate al senza suono, oltre che al senza senso e al senza amore, di vittime di una storia che procede e che immancabilmente riesce a sopraffarle.
Nasce qui un testo di Gatto giustamente famoso come Amore della vita, forte della musicale lapidarietà di
un endecasillabo così isolato e così memorabile come «Tutto di noi gran tempo ebbe la morte», rilevato con icasticità soggettiva in apparenza degna di un autoritratto di Alfieri, ma pronunciato a
nome di molti.
Un’unica storia e tante vittime che la poesia di Gatto svolge tra
recitativi e cantabili anche quando non sembrerebbe, o meglio anche quando questa tensione a un «altro mondo» che in Gatto, come Luigi Baldacci ha dimostrato, viene allestendosi preminentemente per via musicale, questa
confluenza nell’a-temporale e nell’a-sociologico della poesia, non si è ancora
espressamente definita come un civile intento di poetica: come un proposito da moralità
se non aggiunta rafforzata. Un proposito volto a ricollegarsi direttamente alle tragiche contingenze di una cronaca e di una storia recente, un deliberato e dirimente obbiettivo della volontà fattosi opera: un plurale, internamente scandito ma
unitario, racconto di vite.
Marco Marchi
25 Aprile
La chiusa angoscia delle notti, il pianto
delle mamme annerite sulla neve
accanto ai figli uccisi, l'ululato
nel vento, nelle tenebre, dei lupi
assediati con la propria strage,
la speranza che dentro ci svegliava
oltre l'orrore le parole udite
dalla bocca fermissima dei morti
"liberate l'Italia, Curiel vuole
essere avvolto nella sua bandiera":
tutto quel giorno ruppe nella vita
con la piena del sangue, nell'azzurro
il rosso palpitò come una gola.
E fummo vivi, insorti con il taglio
ridente della bocca, pieni gli occhi
piena la mano nel suo pugno: il cuore
d'improvviso ci apparve in mezzo al petto.
Alfonso Gatto
(da La storia delle vittime, 1966)

Come un nuovo Edipo.
Bartolo Cattafi
Il viaggio della vita del siciliano Bartolo Cattafi (nato a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, il 6 luglio 1922, morto a Milano il 13 marzo 1979) è stato anche un viaggio della poesia, della affidabilità o meno dei suoi oracoli, della sua stessa pretesa configurazione divinatorio-conoscitiva depositaria, mediante parole, di rivelazioni.
Nuovo Edipo di fronte alla vita, costretto alla vista inammissibile della inammissibile vita, Bartolo Cattafi ha presto capito, grazie alla poesia, che il reale, per essere penetrato, colpito, fissato e così certificato, richiede efferatezze. La vita, la vista... Così scrive in un suo testo il poeta: «Mi chiudo nel guscio delle palpebre / cammino e incespico» (Me ne vado, in La discesa al trono). Stanchezze del viaggiatore dimissionario? Peregrinazione coincidente con l'immobilità, dislocazioni e spostamenti ormai senza confini, ormai senza tempo e ancora senza senso?
«In aegra urbe», con Edipo, fra destino ed inconscio, classicismo e surrealismo. «In aegra urbe»: all’incrocio di tutte le strade, a quel fatidico, unico «trivium» da tenere a mente con il ricorso alla musica di Stravinskij su libretto di Cocteau come altro modo di esprimere lo smarrimento, la crisi permanente: di fare per via di freudismo classicamente rimodellato, espressionismo oggettuale, coriaceo e quasi categoriale, senza gridi. Nient’altro, insomma, all’infuori del «trivium» degli oggetti stessi perlustrati nella loro fisicità simbolica e formale, l'incrocio in cui canalizzare la protesta, il disagio che tutto investe.
Un viaggio della vista che corrisponde all’unico viaggio della vita: che lo compendia, che, ripetendolo, lo rende sempre odierno ed allarmante, con un vecchio ucciso all’incrocio di tre strade. La vista, l’accecamento dinanzi al vero, il racconto di un enigma già dato, e per la poesia di Cattafi – una di sicuro delle esperienze poetiche più valide del nostro secondo Novecento – lo sconfinamento nell’atemporale, o meglio in una sorta di integrale cronismo attaccato ai suoi fitti dati di riferimento quanto storicamente sfiduciato; uno sconfinamento nel matericamente assolutizzato, momentaneo e casuale e insieme mitico e fondante.
«Dov’è l’antica Grecia / con dracme sonore / come il mare d’Omero?», si chiederanno alcuni versi di Storia, nelle precoci ma già del tutto orientanti Mosche del meriggio. Tre strade che s’incrociano, o quella geografica «Terra dei Tre Capi» citata per via di Ulisse da Omero: una «ricca, fiera, boscosa» geometricamente disposta e percorribile «da un cateto all’altro», che però «Se vi sbarchi è come / un approdo in Nordafrica / o al Partenone / in un’aria di semicolonia / e si è metà dentro metà fuori / di un chiaro capitolo di storia» (Thrinakie, in L’osso, l’anima).
E un’altra Grecia ancora, alternativa, incrociata e innaturale anch’essa, modernamente disarmonica e conflittuale, cui tuttavia di nuovo la poesia partecipa, con l’ambiguità che è tipica dei suoi responsi, delle sue ieratiche e insindacabili presenze: essa stessa, la poesia, nelle vesti sontuosamente materne, attraenti e paurose di un’estrema Giocasta. O come scrigno del leopardiano «crudo vero», o come arduo, residuale e dirompente messaggio del divino: di quel Dio maiuscolo della terminale Allodola ottobrina cui tenersi aggrappati, nell’insaziato accertamento della sconfitta e nell’attesa.
Marco Marchi
Tabula rasa
D'accordo, amore. Espungiamo
dal testo perle d'acqua
su petali,
le frange estese,
le bolle schiuma.
Le cose lietamente necessarie.
Togliamo anche
l'acqua l'aria il pane.
Giunti all'osso buttiamo
fuori della vita
l'osso, l'anima,
per credere alla tua
tabula che mai
avrà l'icona, l'idolo, la cara calamita?
Bartolo Cattafi
(da L'osso, l'anima)

Le cicale di Tozzi
Il testo tozziano che abbiamo scelto, Le cicale, trova in un bambino, e per di più in un bambino che è il proprio figlio, un personaggio della storia e un destinatario-interlocutore cui rivolgersi ideali. Raccontando di cose semplici, affidandosi alla prosa breve del frammento e dell’appunto, tenendo costantemente presente, soprattutto, l’esemplarità del colloquio instaurato, Federigo Tozzi ci si presenta, pure in queste pagine particolari e sufficientemente rare, con gli attributi del grande scrittore. La sua poetica esigente e intransigente non gli concede tergiversazioni, tanto meno deviazioni o bruschi cambiamenti di rotta. Ogni spunto di questa registrata vita infantile in campagna, per episodi e intermittenze da diario di un’estate, rimanda a quella specola privilegiata (e qui finanche decisiva, affettivamente coinvolta come freudianamente si presenta) da cui si osservano e si rappresentano i “misteriosi atti nostri”.
La natura, un figlio, un padre: si ricrea, in stringatissima sintesi e in un certo senso alla rovescia, non solo l’implicante rapporto Pietro-Domenico di Con gli occhi chiusi, letterariamente propulsivo e proiettato su analoghi scenari campestri, ma la struttura profonda, costitutiva, su cui poggia e concresce l’intera opera di Tozzi. Leggendo Le cicale un libro come Bestie sembra dilatarsi e arricchirsi (si pensi alla prosa C’era una fonte del colore come quando si sogna..., con quel finale secco e crudelmente inatteso riservato a una “cicala affogata”); persino un titolo iridescente e bellissimo come quello del romanzo-capolavoro dell’autore senese trova concomitanze stringenti, dal vento “che fa male agli occhi” alla foglia che staccandosi dal ramo batte sugli occhi “facendoteli chiudere”.
È giocoforza che quei metaforici “balocchi vivi dell’estate” calamitanti, filtrati appunto in queste pagine attraverso la sensibilità stupita ed acutissima di scoperte e reazioni infantili, riconducano Tozzi ai temi prediletti del suo pessimismo, alla sua visione integralmente tragica dell’esistenza che ha fatto ricordare a più di uno dei suoi lettori più attenti il nome di Leopardi: il dolore e l’inganno, la sopraffazione e la cattiveria, il falso, l’impossibilità comunicativa, la solitudine, la morte. Tutto questo attraverso una sorta di realistica presa diretta di scene dell’innocenza in cui pure il rapporto tra chi scrive e il bambino è ambiguamente identificativo e all’insegna della distanza.
Altrettanto dirimente ed impietosamente accondiscesa la relazione che viene ad instaurarsi tra essere umano ed animale, per comprendere la quale servirà riferirsi alla cultura di Tozzi, un preteso scrittore ingenuo che però conosceva la Bibbia e la letteratura dei mistici, o un presunto scrittore patologico che tuttavia frequentava con ampiezza testi di psicologia: fino ad una conoscenza – e la Siena di Tozzi non era certo la Trieste di Svevo – delle idee freudiane dei Tre saggi sulla sessualità.
In un’opera del pragmatista americano William James, saldando ricerca scientifica e ricerca religiosa, Tozzi poteva d’altronde recuperare affermazioni di questo tipo: “Certo, io pensavo, io sono abbandonato da Dio (...) ed ero dolente che Dio mi avesse creato Uomo. Gli animali, io benedicevo la loro condizione, poiché essi non posseggono una natura peccatrice, essi non sono invisi a Dio nella sua ira, non sono predestinati alle fiamme infernali dopo la morte. (...) lo benedicevo ora la condizione del cane e del rospo”.
Si procede così nel confronto promosso dalle cicale, dalla loro presenza inquietante di “larve maturate sotto terra”, creature un po’ repellenti nella loro strana corporeità e tuttavia meravigliosamente sbocciate al canto, regine kierkegaardiane dell’oltre-lingua, laddove il dominio della musica è incontrastato.
Ed ecco – tra fascini del sillabario di Glauco scolaretto, magie del telefono, parole che si vorrebbero toccare, silenzi espressivi, e insieme violenze perpetrate e subite, colpe, uccisioni e morti spontanee – la “firma” di Tozzi. La soleggiatissima estate panica che in sintonia con D’Annunzio lo scrittore aveva a suo tempo celebrato nelle sue poesie e in alcuni aforismi di Barche capovolte rivela il suo “negativo”, permettendo l’individuazione di un punto oscuro, luogo di raccolta putrescente e nauseabondo di “tutti gli umori neri del podere”. L’idea di un Eden contaminato ab origine e irrimediabilmente corrotto non abbandona l’immaginario di Tozzi.
Il sole abbacina, gli occhi si chiudono, le tripudianti cicale cedono letterariamente – con il nulla e il silenzio minacciosamente incombenti – alla novecentesca “vita brulla” degli ormai imminenti Ossi di seppia montaliani: “Debole sistro al vento / d’una persa cicala...”.
Ma qui, prima che sia autunno e che la musica delle cicale scompaia, c’è anche da godere, assieme a un bambino felice e in gran parte ancora inconsapevole, la serenità attimale di una giornata inondata di luce, piena di segni di riconciliazione appena contraddetti: “La tovaglia è candida, ed ha ombre azzurre che si vedono a pena; gli orli dei piatti e dei bicchieri luccicano; la bottiglia dell’acqua riflette come uno specchio la luce bianca che vi scintilla dentro; anche il vino fa al collo del fiasco un dischetto del color del cielo; i dorsi delle sedie lustrano, il pavimento s’illumina; e forse le pareti diventeranno diafane”.
Marco Marchi
Da Le cicale
Senza sapere il male che facevi, hai strappato quasi tutti i nuovi innesti alle viti.
Ti vorrei brontolare; ma mi ricordo che anche io, quasi alla tua età, feci lo stesso.
Però per farti capire quello che non ti dico, smetto di parlarti; e anche tu, allora, non pensi più a me.
Io penso a quelle viti, che non avranno l’uva; e ai contadini che lasceranno il filare con il paniere vuoto.
Penso alle viti che forse solo tra un anno ributteranno un altro tralcio giù dalle radici, a fior di terra; ed allora potrò potarle come voglio. E tu sari più grande e non le sciuperai.
Anche quell’uva si maturerà. E la vedrò pestare dentro i bigonzi, dopo che l’avrò assaggiata. Ma certo non sarà come quella degli innesti; per colpa tua.
Cinque panieri di meno; e sarebbero state viti da farne magari il doppio. Gli innesti erano buoni, tagliati dalle viti di pianura; di quelle che resistono anche alla peronospera. Miu dispiace di più, vedendo le altre viti tanto belle!
Vedi che, anche, ci sono parecchi frutti! Anche i peri faranno presto. C’è un pero che è il prim’anno a maturare: Se piove a tempo, le ciliege saranno più grosse.
Ma tu mi chiedi, all’improvviso:
– Le cicale che mangiano?
*
È una giornata serena che anch’io divento di buon umore, e mi piace, Glauco, che tu sia così gaio.
Tu ridi aspettando che la minestra sia pronta; e mi guardi, sboccoccellando il pane tagliato per te.
La tovaglia è candida, ed ha ombre azzurre che si vedono a pena; gli orli dei piatti e dei bicchieri luccicano; la bottiglia dell’acqua riflette come uno specchio la luce bianca che vi scintilla dentro; anche il vino fa al collo del fiasco un dischetto del color del cielo; i dorsi delle sedie lustrano, il pavimento s’illumina; e forse le pareti diventeranno diafane.
Ma io sento che basterebbe un nulla per turbare questa pace; e perciò sono anche nervoso.
E tu mi dici che stasera piglierai due cicale al meno.
*
È autunno , e le cicale non le senti più: Ma ci fai presto l’abitudine, perché vedi l’uva matura e mangi i fichi quando riesci a farteli dare:
Fino ad un altro anno, non le ricorderai né meno.
Federigo Tozzi

Il corpo e l’anima.
Giovanni Raboni
Il corpo, l'anima... Ha scritto Giovanni Raboni a proposito di Claudel: «Si è sempre insistito molto – e, curiosamente, sia da parte dei suoi ammiratori che da parte dei suoi detrattori – sulla “materialità” dell’ispirazione e della scrittura di Claudel, sul fortissimo tasso di “corporalità” presente nella sua poesia lirica e teatrale. Cito, per tutti, Thibaudet […]: per Thibaudet, Claudel è “poeta della materialità dei dogmi, delle devozioni, dei sacramenti, delle immagini, di tutto quanto la religione, essendo umana, può e deve comportare di corporale…”. Descrizione precisa, e da sottoscrivere, ma con una correzione o precisazione essenziale: oltre e più che la religione con i suoi apparati e le sue cerimonie, è il mondo intero – il Creato, appunto, con il suo drammatico, atroce, esaltante convivere e combattersi di materia e di spirito, di carne e di anima, di impurissimi corpi e di purissime voci – ad apparire a Claudel come un tutto inscindibile, all’interno del quale non c’è pensiero che non pesi e non sanguini e non c’è ferita per quanto infetta e purulenta da cui non si sprigioni un sospetto, un profumo di salvezza» (Claudel, il corpo e le voci, nel collettaneo La poetica della fede nel ‘900. Letteratura e cattolicesimo nel secolo della «morte di Dio», Liberal Libri 2000).
A tanto caro sangue, appunto, tra le cellule stesse, vorremmo dire, di quella «membrana segreta» che, unendo e separando, coniuga, articola, dà respiro a tutto ciò che esiste. Il poeta Giovanni Raboni ritrova qui, al cospetto di un conflitto ineludibile in ogni seria visione del mondo, il suo problema, la sua luminescente oscurità da – cito – «religiosa esperienza del nulla» (la definizione, perfetta, è di Luigi Baldacci), il suo profilo stesso di individuo creante da autobiografia differita, da misteriosa «vita scritta» rinvenibile senza cesure in quella scritta da altri: una «vita scritta» già vissuta e ancora da vivere nei conati insoddisfatti da «sfrattato dal tempo», da poeta «semivivo» e «semimorto» attratto da «barlumi», rilkianamente memore di un «altrove», teso e disteso. comunicante: «Tanto difficile da immaginare, / davvero il paradiso? Ma se basta / chiudere gli occhi per vederlo, sta / lì dietro, dietro le palpebre, pare // che aspetti noi, noi e nessun altro, festa / mattutina, gloria crepuscolare / sulla città invulnerata, sul mare / di prima della diaspora – e si desta // allora, non la senti? una lontana / voce, lontana e più vicina come / se non l’orecchio ne vibrasse ma // un altro labirinto, una membrana / segreta, tesa nel buio a metà / fra il niente e il cuore, fra il silenzio e il nome…» (Tanto difficile da immaginare, in Quare tristis).
Prosegue Raboni critico, ancora riferendosi a Claudel: «In altre parole, il centro del suo sentire – e, dunque, del suo voler dire – c’è l’idea incombente, terribile, irrinunciabile dell’Incarnazione: un’incarnazione, per così dire, perpetua, mai veramente compiuta, sempre da ricominciare, che coinvolge tutti perché tutte le anime devono, in qualche momento misterioso e fatale della loro storia, “sforzarsi” di diventare corpi, di acquistare la dolorosa e gloriosa grevità della materia, così come in un altro momento non meno misterioso e non meno fatale tutti i corpi devono “sforzarsi” di uscire da se stessi, di liberarsi del proprio peso».
La poesia non abbandona chi a lei si dedica, chi lei ricerca, presupponendola, pronto ad ogni evenienza, «qualcosa di possibile». A tal punto che nell’arduo e per certi aspetti clamoroso passaggio raboniano dal riassuntivo A tanto caro sangue: poesie 1953-1987 ad una nuova fase inaugurata dai Versi guerrieri e amorosi sarà possibile riconoscere non tanto una smentita o un drastico mutamento di rotta, una resa o un’irresistibile illusione plagiante, quanto una complementarità, una continuità, un ulteriore – segreto ed imprevisto quanto si vuole ma anche per questo gioioso, naturale – ritrovamento dell’espressione: «Morto per loro, e presto: ma con lei / tanto consente il cuore / che è di vecchiaia che vorrei morire»; e a ruota, a suggello delle bellissime Reliquie arnaldine: «Vacilla il cuore e sbanda / se di lei solo gli occhi hanno vivanda / e palpitando a sapere m’invita / che questa poca vita è la mia vita».
Marco Marchi
Invecchiando il corpo vorrebbe un'anima
Invecchiando il corpo vorrebbe un'anima
diversa ma come si fa? non serve
prendere calmanti, stordire i nervi
e la mente, il problema è proprio l'anima,
l'anima che non vuole pace, l'anima
insaziabile, ostinata che ferve
per sempre più comicamente impervi
labirinti o abissi e si sa che l'anima
non solo è immortale ma immortalmente
immatura. Così, temo, non resta
che rassegnarsi, finché non s'arresta
la fontanella del respiro niente
può cambiare, non è di questo fuoco
spegnersi come gli altri a poco a poco.
Giovanni Raboni

Il dolore e la gioia
Margherita Guidacci
Vale davvero la pena dedicare a Margherita Guidacci uno dei nostri interventi, dato che non sono stati molti i ricordi per così dire all’altezza della situazione che dopo la sua scomparsa le sono stati tributati. Restano soprattutto, assieme ad assaggi dai suoi cartegggi, un ampio e qualificato convegno di studi tenuto nell’ormai lontano 1999 tra Firenze e Scarperia (la Guidacci, che là soggiornava d’estate, era tra l’altro cugina dello scrittore Nicola Lisi) e la meritoria raccolta di tutta la sua opera in versi in un unico volume, a cura di Maura Del Serra, per Le Lettere.
Eppure nella poesia del secondo Novecento la Guidacci ha senz’altro costituito una presenza di rilievo: appartata, deliberatamente solitaria, fieramente lontana dalle cronache e dalle mode, ma proprio mediante queste forme di solitudine – scambiate, a torto, per superbia – originale e storicamente efficiente.
Scriveva Emily Dickinson in una delle sue bellissime lettere a suo tempo tradotte dalla Guidacci: «Dipingerei un quadro capace di commuovere fino alle lacrime, se avessi la tela adatta, e la scena sarebbe la solitudine, e le figure solitudine, e in ogni luce, ogni ombra una solitudine. Potrei empire una sala di paesaggi così pieni di solitudine che gli uomini vi sosterebbero davanti a piangere, e poi si affretterebbero verso le loro case, grati di ritrovarvi un essere amato».
Anche Margherita Guidacci ha conosciuto la solitudine, perfino l'incapacità a restituirne in parole e poetici oggetti d’arte la sua tragica morsa; ma ha conosciuto pure una solitudine generatrice di poesia. Alcuni dei suoi libri più belli, anzi, rimangono quelli all’insegna di un disagio patito sulla propria pelle, fattosi biologia dolorante: Neurosuite, soprattutto, del 1970, e Il vuoto e le forme, uscito sette anni dopo con la prefazione di Luigi Baldacci, che con la Guidacci aveva condiviso un magistero accademico sensibile ai valori poetici come quello di De Robertis, il critico di Foscolo e Leopardi, il critico di Ungaretti.
Fin da allora la Guidacci si era imposta con una lirica controcorrente, di forte afflato religioso e sostanzialmente antiermetica. Una poesia di «significati in drammatico accostamento» e non di «magici suoni»; una poesia della chiarezza, da «tersi cristalli» anche se proveniente dall’oscurità dei conflitti, dalla crisi stessa di un’ispirazione sotto il segno della fede e delle speranze ad essa connesse.
A un certo punto il negativo si era imposto, aveva avuto corso: drammaticamente. Basti citare, da Il vuoto e le forme, questo splendido sillogismo della consapevolezza, da cartesianesimo rovesciato o incupito agostinismo degno della Città di Dio: «Non penso dunque sono e non amo / dunque sono e non spero non agisco e non sento. / Vuoto in fronte e alle spalle. Non sono dunque sono: / dunque sono tua figlia, mio disperato tempo».
Poi, all’improvviso e trascinando nella risalita la poesia, la solitudine era stata annullata da un miracolo d’amore, e il contatto aveva subito prodotto parole, se l’essere umano toccato da Amore diventa solo per questo, secondo Platone, poeta.
Con le liriche di Inno alla gioia, in un poeta a rischio semmai di doversi con l’amore smentire nei suoi esiti maggiori, l’esultanza trovava nel 1983 i suoi accenti, diventava inno rivolto a quella gioia, inducendo a sperimentare fin dalla scelta del titolo di un canzoniere così prorompente, così pieno e certo di sé, la retorica di citazioni ritrovate negli altri. Sì: Inno alla gioia, e non come un facile segnale culturalistico, ma come necessità, come sorgiva invenzione nonostante Schiller e Beethoven.
E ne nascevano versi come questi, irrefrenabili e tripudianti, fermi e gioiosi pure nel ricordare ciò che fu: «Il dolore / era piombo e pietra e mi chiudeva in me stessa. / Ogni giorno una nuova cerchia di mura, / un nuovo giro di catene. // Ma la gioia / mi dilata ora dal centro del cuore / fino agli orli vibranti del mio essere – / leggera come un fiore che apra i suoi petali... / No, più leggera. Io sono spazio e luce. / Sono il crocevia di liberi venti».
Marco Marchi
È come una mancanza di respiro
È come una mancanza di respiro
e un senso di morire
quando mi stringe improvviso
il desiderio di te tanto lontano
e nulla può calmarlo, altro pensiero
non può occuparmi, tranne il Paradiso
che sarebbe per me lo starti accanto.
Ma poiché ciò m’è negato, più cara,
molto più cara d’una fredda pace
mi è la stretta indicibile -
quasi marchio di fuoco che proclami
ancora e sempre quanto sono tua.
A nessun costo vorrei separarmi
da questo mio dolore.
Margherita Guidacci

Lettera
a
Daria Menicanti
Daria carissima,
come stai? Ma che fine hai fatto? È da tempo (da tanto tempo, tanto per davvero, ogni anno che passa sempre di più) che mancavo di tue notizie, di sicuro non per tua colpa, dal momento che troppo forte è stata, è e sempre sarà la nostra amicizia. Ma neppure io, in realtà, sono stato in grado di dartene, di notizie: notizie e aggiornamenti costanti, voglio dire, così puntuali e frequenti come era nostra abitudine, affidati alla scrittura di lettere non meno che al filo del telefono.
Un rapporto molto intenso e senza ombre, anche se sempre svoltosi, rigorosamente e un po’ paradossalmente, a distanza: senza mai stringerci la mano o meglio senza mai abbracciarci, da veri amici, presumendo di conoscerci già bene, e forse meglio che in ogni altro modo, proprio così, e finendo col delegare a qualche classica foto da epistolografia della lontananza o ad un casuale o medianico riconoscimento televisivo a tarda notte in un TG (era, lo ricordo bene, un convegno fiorentino su «Solaria», e la datazione potrebbe quindi essere esatta) i lineamenti salienti della nostra fisicità differita, altrimenti dislocata e risolta.
Del nostro dialogo, parte più qualificata e profonda, inutile dirlo, era e resta quella della tua poesia: versi che fin dalla prima lettura che ebbi occasione di farne su uno dei tuoi libri forti, Poesie per un passante, ha sempre giocato su di me un potere attrattivo e fascinatorio notevole. Tanto è vero che da allora non ti ho più lasciata; tanto è vero che, oltre che tuo amico, sono stato uno dei tuo critici, e con mia massima soddisfazione il critico cui decidesti un giorno, attribuendomi un privilegio inatteso, di affidare la presentazione di un altro dei tuoi libri più felici e decisivi: quel Ferragosto nel quale ad ogni pagina potevo ritrovare all’epoca, a livelli di distillata esemplarità e assolutezza, quell’idea di poesia di cui tanto parlavamo assieme, che tu realizzavi scrivendo e nella quale io mi ritrovavo.
E fu in effetti attraverso le poesie di Ferragosto, nel 1986, trent'anni fa, che potei indicare con maggiore chiarezza di quanto prima fossi riuscito a fare un mio modo di leggerti e di apprezzarti: Daria Menicanti come una poetessa dalle «belle maniere» (la civiltà basata su un allargato ambiente di maestri e compagni di cui eri portavoce umile e scrupolosa pure in minimi eventi della quotidianità) che attraverso quelle sapide e concentrate «belle maniere», non necessariamente pure e semplici convenzioni senza peso, lanciava in realtà messaggi tutt’altro che innocui o rassicuranti, anzi singolarmente implicanti e spregiudicati: originali fino ai ribaltamenti più rivelatori, fino alle oltranze e agli scandali di cui l’arte è capace; fino agli sbaraglianti «fuori programma», appunto, in cui la pur necessaria e per certi aspetti inderogabile consapevolezza di chi scrive deve per forza di cose cedere a quella verità rilkiana che, testimoniando dell’ispirazione e delle sue regole, prevede a un certo punto una mano che inizia a muoversi senza sapere perché, dirigendosi non si sa verso quali zone e verso quali traguardi. Era dentro la tua poesia, insomma, intimamente, anche il tuo filosofico, banfiano e pretiano «dubbio» trionfava: un dubbio culturalmente maturato e fattosi perfino condivisione biografica che deragliava inaspettatamente, per via di scrittura, in più alte e complesse forme di conoscenza che sfarinavano la sua granitica e molecolare invadenza in ogni esistenziale accadimento.
Questa idea di poesia double face che nel tuo lavoro si celebra mi sconcerta e mi attrae, Daria, e sarei ancora disposto a citare per te Djuna Barnes e il suo splendido, cangiante nightwood da «labbra insanguinate» di progenitori selvaggi, da ibridi e sorprese da nuova creazione: da antinaturalistici incroci, vorrei dire, che a ben vedere veicolano un’altra delle modalità comportamentistiche o linee portanti della tua poesia, della tua stessa protratta dedizione ai suoi lucidi ed oscuri misteri.
Parlavo ancora, esprimendomi sugli esiti di Ferragosto, di «francescanesimo hard». Ma ciò non ha impedito affatto alla tua poesia, agli antipodi mettiamo rispetto al magnifico creaturismo di Betocchi, di aprirsi a una dimensione creaturale: una dimensione sostanzialmente antiumanistica, incircoscritta ed ecumenica, tutta nel segno del realismo che più conta e di una smaliziata, ironica esperienza di come va il mondo. E anche in questa apertura professata in re, all’interno delle tue invenzioni e non fuori di esse o a margine, Daria, altro che «care cose» (citandoti), altro che «vezzi e zuccheri» (citandomi ancora dalla prefazione di Ferragosto)!
Ricordo quanto ti scrissi in una lettera diventata aperta che, manco a dirlo, in linea con i nostri interrogativi e nondimeno con le nostre imperturbabili fiducie nella poesia, si intitolava Essere cavallo e diceva:
«Cara Daria, Daria carissima, grazie dell’antologia, bestiario e “piantario” assieme. Il titolo che hai scelto, Altri amici, è tutto tuo: è giusto, ti rispecchia fedelmente come la raccolta a cui presiede. Ma ho fatto subito anch’io, da lettore innamorato dei tuoi versi, la mia antologia, e ho selezionato, scelta più personale non si può, due sole poesie. Mi sono interessate, oggi giovedì 9 ottobre 1986, Andrea cavallo e soprattutto quell’Essere cavallo, per certi aspetti anticipo della Madame Centaure che dà mirabilmente il via al tuo più bel libro, Ferragosto. È un desiderio in un titolo, Essere cavallo, un sogno, né più né meno di quanto avveniva nella serie ottativa a suggello dell’antica Riviere di Montale; con la differenza che tu, fondamentalmente, vuoi essere cavallo e basta, e sai di esserlo a tutti gli effetti, per accertate discendenze. Vuoi essere, però, un cavallo “civile”, “regolarmente iscritto”, per battere i tuoi zoccoli. Meglio San Siro o Piazza Duomo? Alla domanda rispondono i testi che scrivi.
Non so, d’altra parte, se l’Andrea del primo componimento scelto sia rimasto completamente soddisfatto dell’identificazione con un gentleman che hai autorizzato con sicurezza per lui. Ti dico solo che, nel caso la cosa non lo avesse perlomeno non irritato, Andrea starebbe con te, con me, con l’Eliot che criticava in tutti noi l’attaccamento agli «oggetti creati». La stigmatizzazione non esclude il fascino: si limita a complicare, a complicare positivamente. E la tua poesia (hai fatto benissimo a intitolare questa raccolta Altri amici, ne sono convinto) nasce da qui, da una frizione-base che la firma in maniera indelebile, che non si può sbagliare. “Ognuno riconosce i suoi – ricordi? –, e i mostri di quel tipo riconosceranno quelli e non altri mostri”».
Un saluto affettuoso, ancora una volta, dal tuo fedelissimo
Marco Marchi
Madame Centaure
Mansueta e pigra come lo è ogni femmina
se non ha liti in corso, Madame
Centaure per la piazza deserta
procede al trotto. Posa sul selciato
delicata gli zoccoli, lucendo
solleva impudica la coda di seta.
Sotto il sole d'agosto la città
per pochi superstiti improvvisa
tali eleganze, tali allucinazioni

Daria Menicanti
(da Ferragosto, Lunarionuovo 1986, ora in Il concerto del grillo, Mimesis 2013)
L’ispirazione
secondo Betocchi
I teorici della letteratura lo chiamano l’«avantesto» ed essendo ciò che precede un testo e nel contempo lo determina, quell'insieme di meccanismi, modalità ed occorrenze che sovrintendono alla sua configurazione definitiva e insieme alla sua più remota origine, può identificarsi anche con ciò che comunemente si dice, senza dover ricorrere a impegnativi tecnicismi da linguaggio speciale, l’ispirazione.
Molti poeti, del resto, hanno amato fornire indicazioni su come in loro si produca la poesia, in che modo in loro si presenti, si faccia strada e richieda soddisfazione, obbedienza. Indicazioni e attestazioni quanto mai varie e divergenti, a vantaggio talvolta del senso, talvolta del suono (penso al Pasolini casarsese folgorato da una parola sentita pronunciare come «rosada»; penso al Valéry di Le Cimitière marin, alla sua certificazione circa un irresistibile richiamo metrico, ritmico-accentuativo preciso, di valore primario), che quella misteriosa danza e controdanza in atto tra significante e significato implica.
Anche il grande Carlo Betocchi ha raccontato come in lui la poesia
prendesse forma, come di volta in volta, testo dopo testo, miracolosamente si realizzasse, e lo ha fatto affidando la sua testimonianza ad una stupefacente prosa dal
titolo Diario della poesia e della rima, apparsa come una sorta di postfazione o
allegato prezioso che dir si voglia a un suo libro tardo, cronologicamente diffuso e compendiario: Poesie del
Sabato, pubblicato per le cure di Sauro Albisani nella prestigiosa collana
dello «Specchio» di Mondadori nel 1980. Nel fare questo, parlando di poesia, Betocchi restava magnificamente poeta: quel poeta da «anima di tutti» che la sua poesia rigorosamente umile e
creaturale, dai lontani tempi del debutto di Realtà vince il sogno a quelli degli ultimi versi, ha sempre
rappresentato, ascoltato e cantato.
Ecco allora un breve estratto dal Diario della poesia e della rima che, cogliendo il punto in cui l’ispirazione si materializza in suoni e accenti, parole e immagini, produce
anche – proprio nel registrare la
fenomenologia di quel misterioso processo generativo – altra poesia: un'altra, per dirla con il linguaggio di Betocchi, «vicenda di parole».
Leggete, giudicate e dite se non è così. E dite anche se Carlo Betocchi, perfino in una prosastica e strumentale dichiarazione a margine della poesia come questa, si riveli o no con i suoi tratti di riconoscimento più propri: tratti inconfondibili che, nonostante i fraintendimenti e le dimenticanze che colpevolmente gravano sulla sua opera, consentono di identificarlo con assoluta sicurezza come un poeta tra i massimi che il Novecento italiano può vantare.
Marco Marchi
da
Diario della poesia e della rima
Tu hai nel petto un garbuglio di cose che ronzano come un’arnia d’api al lavoro. S’apre uno spiraglio nell’arnia; il capo del
verso, come un’ape d’oro, appare, sull’orlo, fremente, sta per spiccare il volo, e sdipanare il garbuglio dello sciame. E a un tratto, in quel deserto, appare un fiore giallo, a
sinistra, lontano, poi un altro, ma sembra vicino, ed è rosso, sulla destra. Sono apparizioni che sorprendono il poeta: e che fantasticamente si replicano. Altro rosso,
altro giallo, e un violento azzurro punteggiano il deserto: e son parole che contengono un nesso segreto, quasi mostruoso, con quello che vuole il poeta, il suo discorso che ronza,
lo sciame che vola. Quello che era intenzione del discorso si eleva ad altra potenza correndo a investire questi suggerimenti di colori ritmati che moltiplicano secondo il bisogno le loro
apparizioni, le loro corrispondenze.
E il discorso che era tutto dentro l'arnia sta ormai sciamando a precipizio con l'ardente sua fame verso i richiami dei fiori che sbramano la sua passione di impossessarsi di una ragione
sconosciuta.
Ogni fiore era una rima, ed ora capisco che ognuno di essi conteneva un potenziale che il poeta non inventava da sé, ma che rispondeva,
come predisposto, alla supplica ardente di quella fame compressa.
Chi ha assistito a questa vicenda di parole che s'appostano lontano a creare la danza ancora insospettabile della poesia rimata, sa benissimo che da solo non ce l'avrebbe fatta. Una grande carità
è scesa verso la fame d'esprimersi che lo divorava.
Carlo Betocchi
(Diario della poesia e della rima, in Poesie del Sabato)

Anniversario Pasolini 1975-2016
La testimonianza poetica di Pasolini si origina da una chiamata di tipo squisitamente linguistico: una chiamata legata a una parola dialettale come “rosada”, rugiada, sentita risuonare in Friuli in un mattino inondato di sole dell’estate del 1941; una chiamata suggestiva quanto cogente, religiosamente folgorante come nelle conversioni, destinata a siglare l’intera, complessa vicenda artistica e intellettuale pasoliniana.
Pasolini sarà da quel giorno, prima di tutto, un poeta, e la poesia, in tutte le sue praticabili “forme”, sarà l’elemento fondante e unificante della sua presenza nel mondo, del suo messaggio. Un’obbedienza fattasi immediatamente scrittura (“E scrissi subito dei versi”, come testimonierà Pasolini stesso, riferendosi alle Poesie a Casarsa), che presto, per gradi ma con crescente sicurezza, implicherà per lui l’apertura adulta dell’“io” agli altri e al confronto con la Storia: la Storia con le sue ragioni e le sue assurdità, le sue contraddizioni e le sue violenze, le sue ingiustizie e le sue possibilità di riscatto.
Dalla Scoperta di Marx che suggella L’usignolo della Chiesa Cattolica alle Ceneri di Gramsci, dalle raccolte degli anni Sessanta La religione del mio tempo e Poesia in forma di rosa a Trasumanar e organizzar e La nuova gioventù, la produzione in versi di Pasolini registrerà, tra partecipazione collettiva e difesa della persona, implicazioni costanti e a ben vedere sempre più drammaticamente efficienti. Mai dismessa non solo come “vocazione” ma anche come preciso genere letterario, la poesia rivendicherà nel corso degli anni, tra “passione” e “ideologia” e all’insegna di un inesausto sperimentalismo, modalità comportamentistiche, prospettive d’intervento e fiducie ad essa ascrivibili sempre diverse.
Pasolini, com’è noto, aveva a suo tempo individuato nell’endecasillabo e nella terzina dantesca in aggiornata accezione novecentesco-pascoliana un affidabile strumento per raccontare il sociale e la cronaca che si fa Storia: una moderna narratività poetica che trova nei poemetti delle Ceneri di Gramsci la sua tenuta più compatta e il suo momento più alto. Poi, già con le raccolte degli anni Sessanta, la bilancia oscilla pericolosamente: quel tentato equilibrio non regge, quella forma sperimentata con profitto si sfalda e la poesia cambia faccia, prestandosi a mille oltraggi e a mille nuove identificabilità, sino a fare di se stessa, di se stessa com’era un tempo, una contraddizione instante o un recidivo simultaneismo.
Basti pensare al Pasolini che autoterapeuticamente scrive, tra canzoniere d’amore e poesia perduta come l’amato dedicatario Ninetto Davoli, L’hobby del sonetto, ridisegnando nel segreto, in parallelo alle poesie civili confluite in Trasumanar e organizzar, una zona di libertà da quel dovere sociale così pressantemente sentito: un dovere che, falliti i suoi allargati obiettivi d’amore umanamente fondanti e qualificanti, ha analogamente deluso, rendendo impronunciabile la parola “speranza”.
Il poeta si trasforma, la poesia si trasforma, e tuttavia quest'ultima si riconferma strumento privilegiato dell'eresia di Pasolini, finanche sua modalità costitutiva, nel farsi voce alla Rimbaud della disappartenenza di un congenito, consustanziale maladjustement protestatorio nei confronti del reale.
È naturale (e in ciò dissentirei, nella valutazione complessiva del percorso di Pasolini poeta, anche da troppo facili arresti a cronologie alte, laddove cioè la poesia è più agevolmente identificabile come tale, secondo parametri maggioritari condivisi e così sociologicamente autorizzati) che la poesia si faccia diversa, irriconoscibile, disposta a pagare il prezzo della sua diversità nell'affrontare ogni volta da capo il mondo e la Storia, a subire le conseguenze degli scandali e delle delusioni che – sfigurata e irriconoscibile come si presenta – essa stessa determina.
Anche la parola di Pasolini intellettuale si fa all'accorrenza intrattabile e distante come la testimonianza polemica di un vero eretico. È allora che la sua eresia parla per emblemi sibillini, diventa poetico trobar clus, verbo oscuro ribelle alla semantica limitante della convenzione, voce votata all'entropica polisemia e alla deriva di senso.
Il linguaggio diventa simbolico-mistico, inaudito e non integrabile, volto ad operare su un piano di per sé interessato a presentarsi altro, alieno e discontinuo, allestendo un vaticinio problematico e indecente, potenzialmente incompreso, che non ricerca ascolto solidale perché gode, indecentemente appunto, della sua intrattabilità eccessiva e paradossale: dall’antipoetico manifesto in poesia e dalla giornalistica poesia d’intervento sul fatto del giorno al culto, manieristico, solipsistico e dolente sonetto lirico à la manière de Shakespeare.
Marco Marchi
Le ceneri di Gramsci
I
Non è di maggio questa impura aria
che il buio giardino straniero
fa ancora più buio, o l’abbaglia
con cieche schiarite… questo cielo
di bave sopra gli attici giallini
che in semicerchi immensi fanno velo
alle curve del Tevere, ai turchini
monti del Lazio... Spande una mortale
pace, disamorata come i nostri destini,
tra le vecchie muraglie l’autunnale
maggio. In esso c’è il grigiore del mondo,
la fine del decennio in cui ci appare
tra le macerie finito il profondo
e ingenuo sforzo di rifare la vita;
il silenzio, fradicio e infecondo…
Tu giovane, in quel maggio in cui l’errore
era ancora vita, in quel maggio italiano
che alla vita aggiungeva almeno ardore,
quanto meno sventato e impuramente sano
dei nostri padri – non padre, ma umile
fratello – già con la tua magra mano
delineavi l’ideale che illumina
(ma non per noi: tu, morto, e noi
morti ugualmente, con te, nell’umido
giardino) questo silenzio. Non puoi,
lo vedi?, che riposare in questo sito
estraneo, ancora confinato. Noia
patrizia ti è intorno. E, sbiadito,
solo ti giunge qualche colpo d’incudine
alle officine di Testaccio, sopito
nel vespro: tra misere tettoie, nudi
mucchi di latta, ferrivecchi, dove
cantando vizioso un garzone già chiude
la sua giornata, mentre intorno spiove.
II
Tra i due mondi, la tregua, in cui non siamo.
Scelte, dedizioni... altro suono non hanno
ormai che questo del giardino gramo
e nobile, in cui caparbio l’inganno
che attutiva la vita resta nella morte.
Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno
che mostrare la superstite sorte
di gente laica le laiche iscrizioni
in queste grigie pietre, corte
e imponenti. Ancora di passioni
sfrenate senza scandalo son arse
le ossa dei miliardari di nazioni
più grandi; ronzano, quasi mai scomparse,
le ironie dei principi, dei pederasti,
i cui corpi sono nell’urne sparse
inceneriti e non ancora casti.
Qui il silenzio della morte è fede
di un civile silenzio di uomini rimasti
uomini, di un tedio che nel tedio
del Parco, discreto muta: e la città
che, indifferente, lo confina in mezzo
a tuguri e a chiese, empia nella pietà,
vi perde il suo splendore. La sua terra
grassa di ortiche e di legumi dà
questi magri cipressi, questa nera
umidità che chiazza i muri intorno
a smotti ghirigori di bosso, che la sera
rasserenando spegne in disadorni
sentori d’alga... quest’erbetta stenta
e inodora, dove violetta si sprofonda
l’atmosfera, con un brivido di menta,
o fieno marcio, e quieta vi prelude
con diurna malinconia, la spenta
trepidazione della notte. Rude
di clima, dolcissimo di storia, è
tra questi muri il suolo in cui trasuda
altro suolo; questo umido che
ricorda altro umido; e risuonano
– familiari da latitudini e
orizzonti dove inglesi selve coronano
laghi spersi nel cielo, tra praterie
verdi come fosforici biliardi o come
smeraldi: “And O ye Fountains...” – le pie
invocazioni...
III
Uno straccetto rosso, come quello
arrotolato al collo ai partigiani
e, presso l’urna, sul terreno cereo,
diversamente rossi, due gerani.
Lì tu stai, bandito e con dura eleganza
non cattolica, elencato tra estranei
morti: Le ceneri di Gramsci… Tra speranza
e vecchia sfiducia, ti accosto, capitato
per caso in questa magra serra, innanzi
alla tua tomba, al tuo spirito restato
quaggiù tra questi liberi. (O è qualcosa
di diverso, forse, di più estasiato
e anche di più umile, ebbra simbiosi
d’adolescente di sesso con morte…)
E, da questo paese in cui non ebbe posa
la tua tensione, sento quale torto
qui nella quiete delle tombe – e insieme –
quale ragione – nell’inquieta sorte
nostra – tu avessi stilando la supreme
pagine nei giorni del tuo assassinio.
Ecco qui ad attestare il seme
non ancora disperso dell’antico dominio,
questi morti attaccati a un possesso
che affonda nei secoli il suo abominio
e la sua grandezza: e insieme, ossesso,
quel vibrare d’incudini, in sordina,
soffocato e accorante – dal dimesso
rione – ad attestarne la fine.
Ed ecco qui me stesso… povero, vestito
dei panni che i poveri adocchiano in vetrine
dal rozzo splendore, e che ha smarrito
la sporcizia delle più sperdute strade,
delle panche dei tram, da cui stranito
è il mio giorno: mentre sempre più rade
ho di queste vacanze, nel tormento
del mantenermi in vita; e se mi accade
di amare il mondo non è che per violento
e ingenuo amore sensuale
così come, confuso adolescente, un tempo
l’odiai, se in esso mi feriva il male
borghese di me borghese: e ora, scisso
– con te – il mondo, oggetto non appare
di rancore e quasi di mistico
disprezzo, la parte che ne ha il potere?
Eppure senza il tuo rigore, sussisto
perché non scelgo. Vivo nel non volere
del tramontato dopoguerra: amando
il mondo che odio – nella sua miseria
sprezzante e perso – per un oscuro scandalo
della coscienza…
IV
Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere
con te e contro di te; con te nel cuore,
in luce, contro di te nelle buie viscere;
del mio paterno stato traditore
– nel pensiero, in un’ombra di azione –
mi so ad esso attaccato nel calore
degli istinti, dell’estetica passione;
attratto da una vita proletaria
a te anteriore, è per me religione
la sua allegria, non la millenaria
sua lotta: la sua natura, non la sua
coscienza; è la forza originaria
dell’uomo, che nell’atto s’è perduta,
a darle l’ebbrezza della nostalgia,
una luce poetica: ed altro più
io non so dirne, che non sia
giusto ma non sincero, astratto
amore, non accorante simpatia…
Come i poveri povero, mi attacco
come loro a umilianti speranze
come loro per vivere mi batto
ogni giorno. Ma nella desolante
mia condizione di diseredato,
io possiedo: ed è il più esaltante
dei possessi borghesi, lo stato
più assoluto. Ma come io possiedo la storia,
essa mi possiede; ne sono illuminato:
ma a che serve la luce?
V
Non dico l’individuo, il fenomeno
dell’ardore sensuale e sentimentale…
altri vizi esso ha, altro è il nome
e la fatalità del suo peccare…
Ma in esso impastati quali comuni,
prenatali vizi, e quale
oggettivo peccato! Non sono immuni
gli interni e esterni atti, che lo fanno
incarnato alla vita, da nessuna
delle religioni che nella vita stanno,
ipoteca di morte, istituite
a ingannare la luce, a dar luce all’inganno.
Destinate a esser seppellite
le sue spoglie al Verano, è cattolica
la sua lotta con esse: gesuitiche
le manie con cui dispone il cuore;
e ancora più dentro: ha bibliche astuzie
la sua coscienza… e ironico ardore
liberale… e rozza luce, tra i disgusti
di dandy provinciale, di provinciale
salute… Fino alle infime minuzie
in cui sfumano, nel fondo animale,
Autorità e Anarchia… Ben protetto
dall’impura virtù e dall’ebbro peccare,
difendendo una ingenuità di ossesso,
e con quale coscienza!, vive l’io: io,
vivo, eludendo la vita, con nel petto
il senso di una vita che sia oblio
accorante, violento… Ah come
capisco, muto nel fradicio brusio
del vento, qui dov’è muta Roma,
tra i cipressi stancamente sconvolti,
presso te, l’anima il cui graffito suona
Shelley… Come capisco il vortice
dei sentimenti, il capriccio (greco
nel cuore del patrizio, nordico
villeggiante) che lo inghiottì nel cieco
celeste del Tirreno; la carnale
gioia dell’avventura, estetica
e puerile: mentre prostrata l’Italia
come dentro il ventre di un’enorme
cicala, spalanca bianchi litorali,
sparsi nel Lazio di velate torme
di pini, barocchi, di giallognole
radure di ruchetta, dove dorme
col membro gonfio tra gli stracci un sogno
goethiano, il giovincello ciociaro…
Nella maremma, scuri, di stupende fogne
d’erbasaetta in cui si stampa chiaro
il nocciolo, pei viottoli che il buttero
della sua gioventù ricolma ignaro.
Ciecamente fragranti nelle asciutte
curve della Versilia, che sul mare
aggrovigliato, cieco, i tersi stucchi,
le tarsie lievi della sua pasquale
campagna interamente umana,
espone, incupita sul Cinquale,
dipanata sotto le torride Apuane,
i blu vitrei sul rosa… Di scogli,
frane, sconvolti, come per un panico
di fragranza, nella Riviera, molle,
erta, dove il sole lotta con la brezza
a dar suprema soavità agli olii
del mare… E intorno ronza di lietezza
lo sterminato strumento a percussione
del sesso e della luce: così avvezza
ne è l’Italia che non ne trema, come
morta nella sua vita: gridano caldi
da centinaia di porti il nome
del compagno i giovinetti madidi
nel bruno della faccia, tra la gente
rivierasca, presso orti di cardi,
in luride spiaggette…
Mi chiederai tu, morto disadorno,
d’abbandonare questa disperata
passione di essere nel mondo?
Pier Paolo Pasolini
(da Le ceneri di Gramsci, 1957; il poemetto eponimo qui proposto è del 1954)

Nel mondo piccino di Aldo Palazzeschi
Da L’Incendiario – per via di occultamento, contraffazione, sostituzione e riadattamento nell’ambito di rinnovate esigenze espressive – ad una prosa autobiografica di tipo memoriale intitolata Incendiario; dal 1910 (al tempo cioè del futurismo e di Marinetti) al 1932 (negli anni del cosiddetto «ritorno all'ordine»).
A un avanguardistico, mostruoso e seducente Dio del fuoco, della trasgressione e dell’eversione, subentra nel sorridente ed antiavanguardistico Palazzeschi di Stampe dell’800 – reso irreperibile quel mostro – il più conciliativo ed accettabile ritratto di un bambino un po’ troppo vivace di appena tre anni che, da piccolo piromane in famiglia, da sculacciabile incendiario inconsapevole e davvero innocente, fa di una scatola di fiammiferi il suo strumento di affermazione personale, la sua protesta contro oppressive minestre da sorbire tra i confini di invalicabili finestre.
Analogamente, nel capitolo successivo del medesimo libro, allo stesso bambino fattosi solo un po’ più grande, di cinque anni, Palazzeschi memorialista affida l’avventurosa esplorazione dell’esterno, di zone fuori casa, di paesaggi naturali immensi popolati e pericolosi, da evitare. Oltre il divieto, contro il divieto: si affonda ancora nell’infanzia, in quella che un altro scrittore fiorentino, Bruno Cicognani, avrebbe chiamato l’«età favolosa». Veicolato da ricorrenti miniaturizzazioni metaforiche di contrasto (un cagnolino di contro all’elefante) o dagli stessi diminuitivi-vezzeggiativi grammaticali dialogicamente e monologicamente impiegati dalla Piramide del tipo «pollastrino» e «lodoletta» (al femminile, quest’ultimo, in seguito cassato, come in un’opera ora in disuso di Pietro Mascagni), il poeticizzato recupero dell’anelito libertario fuori casa trova ambientazione nelle domenicali Cascine dei Fiori della libertà.
Diffidare, con Palazzeschi, almeno dopo la celebre poesia lacerbiana del ‘13, di ogni genere di fiori e, insieme, di ogni genere di libertà: «Mentre però nei miei cresceva la sicurezza di quel fatto consueto, cresceva in me un desiderio vago di andare un po’ più avanti, dove non arrivavano quegli occhi dai quali mi sentivo tenuto come da un filo: romper quel filo senza saper perché. […] Andavo lungo le siepi alte, fra i grandi tronchi tortuosi, nelle radure o nel folto, levando le gambe fra lo sterpame del basso bosco, fra l’erbe umide, su cui mi piegavo di tanto in tanto per cogliere una pervinca […]. Dove andavo? Senza mèta, senza idea, senza invito… […] Senza paura del buio che veniva, delle ombre che sarebbero discese solenni dalle piante per inghiottirmi, né del vuoto che si faceva intorno in tutto il parco col grigior della sera; senza febbre d’avventura, senza tema e senza gioia; senza curarmi se potesse taluno notare la mia presenza solo in quel luogo e a quell’ora. […] la mia scappata era fine a se stessa: pura».
La «scappatella», insomma, come le esili pervinche raccolte, color del cielo, da piccolo Perelà che, anche chinandosi per fare un mazzolino, guarda in alto, alla sua patria: da ispirato e incurante Cristo fanciullo allontanatosi per fare le cose del Padre suo. Ma ecco, proprio «ad uno svolto», «nella bella foresta artificiale che si chiama “Le Cascine”», «sul luogo del misfatto» e della «colpa», l’incontro: una violenta, sconcertante, traumatica apparizione – mutatis mutandis nel nome di Freud – da Piramide, con un bambino sorpreso, sconcertato, «incapace di prendere l’iniziativa di un passo», «in balìa di quella foga», «incalzato, sbattuto, stiracchiato giù giù per il viale»: «Qualche cosa di enorme mi fu addosso, me ne sentii acciuffato e coperto, sepolto; e senza più distinguere intorno, da un diluvio di colpi percosso, e sopra sotto e dappertutto. Trafelato, gocciolante di sudore mio padre […] mi aveva ritrovato e m’era sopra combattuto tra la felicità di riavermi intatto e di sentirmi suo dopo chi sa quale angoscioso fantasticare, e il bisogno di ripagarsi su me della pena che gli avevo fatto soffrire, facendomi soffrire».
Non il «male», dunque (il cattolico peccato o la «macchia che l’acqua non lava» di un’antica poesia di Lanterna), ma la «purezza», ad avere sollecitato quegli esplorativi e disubbidienti movimenti di fuoriuscita da regole imposte, quegli inspiegabili, misteriosi e suggestivi allontanamenti dall’incipiente sociale e esistenziale conosciuto e ritenuto insufficiente, estraneo, quei lirici primi passi di ricerca dell’io che di infantile màrchiano – per tracce indelebili di uno scandalo che anche così si rivela e di continuo si aggiorna – immaginario, visioni del mondo ed onomastica: Aldino, Valentino, l’omino di fumo, Zeffirino, Giacomino «boccino di rosa», Celestino, Stefanino che di rosa ha perfino la sua coperta di lana di trovatello…
Tutto si fa piccino, proprio come nel minuscolo paese dell’anima cantato in Rio Bo. «E ritornando nel mio bel castello – come si legge nella splendida La mano – / temere d’incontrare / gli sguardi famigliari, / perché possono capire i miei cari / dove sono stato! / Certamente Cherubina ormai à capito, / mi guarda senza dirmi nulla / al mio ritorno, e pensa: / che cattivo marito! / E Stellina, e Cometuzza, / mi guardano con occhio pio pio, / che mi dice assai bene: / dove sei stato, / fratellino mio?». Un castello da lillipuziano e osceno bestiario dell’intimità familiare pronto a farsi solitaria piramide da figurina Talmone o, come in Interrogatorio della Contessa Maria, maliziosa «cameretta» erotica per sottovalutati bambini «piscioni»: bambini in «vestina» e «calzoncini», pretestuosamente alla ricerca su un atlante di isole piccolissime.
Marco Marchi
Rio Bo
Tre casettine
dai tetti aguzzi,
un verde praticello,
un esiguo ruscello: Rio Bo,
un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
paese da nulla, ma però...
c'è sempre disopra una stella,
una grande, magnifica stella,
che a un dipresso...
occhieggia con la punta del cipresso
di Rio Bo.
Una stella innamorata?
Chi sa
se nemmeno ce l'ha
una grande città.
Aldo Palazzeschi
(da Poemi, 1909, poi in Poesie)

L’anima in bicicletta. Giorgio Caproni
Ha dichiarato, in margine ai Versi livornesi che costituiscono la sezione fondamentale della raccolta del 1959 Il seme del
piangere, Giorgio Caproni: «Tentar di far rivivere mia madre come ragazza, mi parve un modo, certo ingenuo, di risarcimento contro le molte sofferenze
e contro la morte».
Il titolo dell’opera – dantesco, scrupolosamente citazionale come sarà molti anni dopo, nel
1975, Il muro della terra – è già memoria: memoria letteraria, con le sue fedeltà e i suoi inganni iperrealistici.
L’epigrafe che apre il libro, comprensiva del sintagma titolativo, chiarisce meccanismi
e significati di una sottoscrizione preliminare indiretta, in apparenza parziale, in realtà protagonistica e complessa nella sua unitarietà di progetto, se siamo rimandati al Purgatorio, canto XXXI, vv. 45-46, e chi
parla a Dante, chi lo rimprovera severamente ben sapendo che anche il silenzio non sarebbe servito a tener nascosta la colpa, è Beatrice. Ampliando il contesto e parafrasando:
«Tuttavia, dal momento che ora provi vergogna del tuo errore, e perché un’altra volta, udendo le lusinghe dei falsi beni, tu sia più forte, deponi la causa delle tue lacrime ed ascolta: così
udrai come la mia morte avrebbe dovuto indirizzarti in altro senso, spingerti non ai beni della terra ma al cielo».
Siamo nel Paradiso terrestre, alle soglie della purificazione necessaria per intraprendere l’ultimo
viaggio: alle requisitorie fanno seguito le esortazioni, all’aspra eloquenza delle reiterate rampogne i lucidi e struggenti argomenti della persuasione. Ed è impossibile non
accorgersi dell’assolutizzazione che Caproni effettua nel privilegiare due endecasillabi esatti,
piegando le ragioni del senso a quelle del suono. «Perché tu sia più forte, per essere più forte», diceva Dante a se stesso per bocca di Beatrice. Al rigore della citazione e del
riferimento bibliografico esibito si abbina la libertà del taglio, portatrice, tra memoria volontaria e
involontaria, di nuove coloriture semantiche: «...Udendo le sirene, sie più forte, / Pon giù il seme del piangere e ascolta...». Quel liberissimo sie, sciolto dagli originari legami subordinativi, rende possibile,
modernamente, la coordinazione, si trasforma in primo appoggio in una serie parificata accresciuta.
Gli imperativi dell’affetto diventano tre, ed è un modo quotidiano di variare e di ripetere un’unica
raccomandazione, meno sottilmente ragionato e invece più sottilmente efficace per rivolgersi a un bambino distratto, abituato a sbagliare e a pretendere quegli immancabili interessamenti per il
suo bene. Un bambino sempre in attesa, se l’arcaico e dantesco
rispitto risulta
rapportabile al provenzale respit. Eppure quel sie
che si presenta genericamente come un congiuntivo rimasto senza appigli è anche, nuovamente per via di memoria, l’indice della precarietà della comunicazione tentata, un preannuncio della casualità e delle pietose convenzioni che
fondano il codice. I collegamenti sono difficilissimi, la linea è disturbata, cade di continuo. Dal poco che di confuso e di interrotto si riesce a ricevere nasce la poesia.
Ed ecco, per via poetica appunto, il «seme del piangere», la dantesca causa delle
lacrime svelata conclusivamente in una poesia proprio così intitolata, attigua a quella Preghiera che qui, nel nome della madre, si propone alla lettura e all'ascolto anche attraverso la voce
del poeta stesso.
Un bambino «debole come un cerino» in una città grande, immensa e sconfinata per lui, ha
cercato per tutto il giorno «la mamma-più-bella-del-mondo», ed essa non c’è più, è via,
si è separata da lui, l’ha lasciato. Il bambino piange «nel buio d’un portone», è il
solo ad aspettare il passaggio di Annina, a richiederlo in una città smisurata,
irriconoscibile, fatta di attese vuote: «Quanta Livorno, nera / d’acqua e – di panchina
– bianca!»; «Via era la camicetta / timida e bianca, viva. / Nessuna cipria copriva / l’odore vuoto del mare / sui Fossi, e il suo sciacquare» (vv. 1-2, 17-21). Il poeta ha
già scritto in A Giannino: «l’amore mio
che stava ad aspettarmi / solo su una panchina» (vv. 3-4). Annina,
intanto, è in un fumoso bar di stazione, anche lei confusa, incapace perfino di scrivere al figlio una cartolina che dica, rasssicurandolo: «Caro, son qui» (Ad portam inferi, v. 30).
L’anima di Caproni, l’arte, è supplicata adesso di pedalare, di volare come Annina
ciclista. Ora la fretta è la poesia. La polisemia del termine
anima è garantita da una fonte sicuramente tenuta presente, come testimoniano analogie tematiche (il motivo del temuto disviamento), puntuali rimbalzi lessicali
(congedo, va’, leggera), un impiego rimico soltanto rovesciato:
«Deh, ballatetta alla tu’ amistate / quest’anima che trema raccomando: menala teco, ne la sua
pietate, / a quella bella donna a cu’ ti mando». Si comincia con Dante e
si finisce con Cavalcanti e ancora con Dante, se nel «dille» del v. 80 si rivela attivo il ricordo del canto VII del Paradiso, vv. 10-12: «Io dubitava, e dicea ‘Dille, dille!’ / fra me: ‘dille dicea, alla mia donna / che mi disseta con le dolci
stille».
Ma è il momento, dopo tanto aspettare, di far arrossire Annina, di gettare la sigaretta che il poeta ha dato all’anima per farsi coraggio e avvicinarsi alla donna. Alla fine il messaggio sussurrato all’orecchio consiste nel dire soltanto da parte di chi è l’ambasciata: «suo figlio, il
suo fidanzato».
Marco Marchi

Preghiera
Anima mia, fa' in fretta.
Ti presto la bicicletta
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare.
Arriverai a Livorno
vedrai, prima di giorno.
Non ci sarà nessuno
ancora, ma uno
per uno guarda chi esce
da ogni portone, e aspetta
(mentre odora di pesce
e di notte il selciato)
la figurina netta,
nei buio, volta al mercato.
Io so che non potrà tardare
oltre quel primo albeggiare.
Pedala, vola. E bada
(un nulla potrebbe bastare)
di non lasciarti sviare
da un’altra, sulla stessa strada.
Livorno, come aggiorna,
col vento una torma
popola di ragazze
aperte come le sue piazze.
Ragazze grandi e vive
ma, attenta!, così sensitive
di reni (ragazze che hanno,
si dice, una dolcezza
tale nel petto, e tale
energia nella stretta)
che, se dovessi arrivare
col bianco vento che fanno,
so bene che andrebbe a finire
che ti lasceresti rapire.
Mia anima, non aspettare,
no, il loro apparire.
Faresti così fallire
con dolore il mio piano,
e io un’altra volta Annina,
di tutte la più mattutina,
vedrei anche a te sfuggita,
ahimè, come già alla vita.
Ricordati perché ti mando:
altro non ti raccomando.
Ricordati che ti dovrà apparire
prima di giorno, e spia
(giacché, non so più come
ho scordato il portone)
da un capo all’altro la via,
da Cors’Amedeo al Cisterone.
Porterà uno scialletto
nero, e una gonna verde.
Terrà stretto sul petto
il borsellino, e d’erbe
già sapendo e di mare
rinfrescato il mattino,
non ti potrai sbagliare
vedendola attraversare.
Seguila prudentemente,
allora, e con la mente
all’erta. E, circospetta,
buttata la sigaretta,
accostati a lei soltanto,
anima, quando il mio pianto
sentirai che di piombo
è diventato in fondo
al mio cuore lontano.
Anche se io, così vecchio,
non potrò darti mano,
tu mormorale all’orecchio
(più lieve del mio sospiro,
messole un braccio in giro
alla vita) in un soffio
ciò ch’io e il mio rimorso
pur parlassimo piano,
non le potremmo mai dire
senza vederla arrossire.
Dille chi ti ha mandato:
suo figlio, il suo fidanzato.
D’altro non ti richiedo.
Poi, va’ pure in congedo.
Giorgio Caproni
(da Versi livornesi, in Il seme del piangere, 1959)
Il Trinci che verrà
Tre nuove poesie di Giacomo Trinci, tre tessere testuali inedite di un libro prossimo ancora in piena formazione.
"Sono componimenti che originariamente facevano parte di un corpus di un centinaio di lieder – ci spiega il poeta –, ciascuno con il suo titolo-argomento. Stavo rileggendo e riflettendo sulla forma che Pasolini stava dando nella raccolta L'hobby del sonetto, decisiva drammatica estrema svolta in cui si cortocircuita lingua della poesia e dell'io in apparente presa diretta. La mia raccolta, liberamente ispirata da questo Pasolini estremo, sposta la forma del suo parasonetto nella sua traduzione in lied per musica, nel sogno di una partitura musicale dove rigore è libertà, rifondazione scandalosa di una lingua in fuga dal già detto, scontato, fondato".
Anche il titolo dell'opera attualmente in progress risulta per il momento incerto, sommamente instabile: vortica attraversa una miriade di possibilità non ancora definite, forse neppure tutte per adesso profilatesi o semplicemente balenate a colui che scrive. Si va dal tentativo di configurare un personaggio già liberato dal peso del corpo-soggetto (il barbone intellettuale già sondato nella sezione dei "passaggi di Barbone" in Inter nos, per cui vedi un nostro precedente post) che un po' leopardianamente rende formalizzabili e come un lascito ci consegna un Libro dei canti, a un titolo più tecnico e internamente ossimorico come Variazioni senza tema, dove appunto il tema assente, la radice prima del poetare che latita e si rende tragicamente irreperibile si situa comunque fuori dal testo, attendendo e nel contempo avanzando, incombendo immobile e pressando: la morte, la padrona di tutto. O ancora, parimenti fuori testo e giocato su raddoppiati paradossi, un titolo come Di vita, troppa (ad oggi, in questa anteprima, titolo di un singolo componimento), con il recupero in sede di sottotitolo o complemento di titolo che dir si voglia, di valore evidentemente antifrastico-parodico, del già codificato Variazioni senza tema.
Sta di fatto che nel libro che verrà di Giacomo Trinci l'assoluto sembra restare decisamente fuoricampo. E' come se il poeta-scriba che qui ci è dato di cogliere al lavoro attraverso tre splendide prove dal suo laboratorio fosse già scomparso, dislocato altrove, funereamente compiuto, finito; ed è come se quel Trinci postumo a se stesso e a tutto ciò che poeticamente ha rappresentato per lui la propria esistenza visitasse il suo scritto estremo da lontano, rintracciando e cercando di mettere a fuoco principalmente – tra scrupolo e splendore, tramite una sorta di comica assolutezza lirica distaccata e insieme straziante, quasi una musica che vuol dire se stessa e nient'altro – il suo essere stato.
Un libro che si preannuncia, insomma, come un grande libro: un vero evento da attendere che sarà sicuramente degno di quella che non da oggi considero una delle voci poetiche più alte e compiutamente riconoscibili della poesia italiana contemporanea. Per me la più sintonicamente vicina e cara, e diciamolo pure, ma quasi tutti lo sanno e da tanto tempo, la prima.
Marco Marchi

TRE POESIE
(di vittima carnefice)
per solo sesso, ti condanni alla castità,
alla perpetua vastità del dare
senza passione
(come un monaco monco
ora mi vedo qui,
ma vedo meglio dallo schermo
di questo termine sfinito
che ghermito m'ha di fragile farfalla
battito d'ala e spillo conficcato),
come un tronco di vita solo vita
che più vita non dà, ma di ferita
avanza un resto che rimane in fine,
e santità di pus, di gas infetto
trattiene me di vittima assassino.
tu dici che la vittima possiede,
tu, che impotente la tormenti in mente
(di vita, troppa)
questo qui vedi,
ma casto di lussurie
lussuriosamente vasto
d'ampie incursioni in mente a lungo, a volo,
depravato d'innocenze, le furie,
tenuto stretto nella vita, intorno,
di veglie, macro, ed indecente;
ma d'astinenze abissali
digiuni e pentimenti sfeci me stesso,
consunto di purezza, corrotto consumai,
non ebbi voglie che non soddisfeci, insoddisfatto,
imperfetto m'estinsi quasi tutto, prima di me;
prima di sfarmi, presi di tutto un po',
non mi contenni mai, fui continente,
mi resta quel che resta qui di tutto:
la tua treccia, canzone, abbandonata.
dura la vita dura, ed io con lei che duro,
anche dopo, d'altrove, oltre ogni muro.
(del vasto e del vano)
quello ch'è vano in te, rendilo niente,
vanificalo puro d'animale,
il sensibile tuo vano di mente
sacrificalo al cielo senza dei,
vita nella tua mano che si sfa
rendila pura d'ogni contingenza,
tu d'ogni circostanza spoglia il fiore,
il cuore del dolore che consola
abiura della sua necessità,
fanne preghiera dura che conforta
che non ha niente fuori d'ogni porta,
quello ch' estraneo suona al tuo passaggio
accogli in te, sbottona la tua veste,
non aggrapparti al fiore d'ogni maggio.
Giacomo Trinci

Marco Marchi insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Ha esordito come saggista nel 1978 con Sul primo Montale, edito da Vallecchi, e ha curato per Mondadori il «Meridiano» delle Opere di Tozzi (1987). Tra le sue pubblicazioni: Pietre di paragone. Poeti del Novecento italiano (1991), Federigo Tozzi. Ipotesi e documenti (1993), Sondaggi novecenteschi. Da Svevo a Pasolini (1994), Palazzeschi e altri sondaggi (1996), Vita scritta di Federigo Tozzi e Vita scritta di Italo Svevo (1997 e 1998), Invito alla lettura di Mario Luzi (1998), D’Annunzio a Firenze e altri studi (2000), Scritture del profondo. Svevo e Tozzi (2000), I mondi di Loria (2002), Novecento. Nuovi sondaggi (2004), Immagine di Tozzi (ivi, 2007), Altro Novecento (ivi, 2009), In breve (Cesati, 2010), Stagioni di Tozzi (Fondazione Monte dei Paschi di Siena-Le Lettere, 2010), Per Luzi (Le Lettere, 2012), Per Palazzeschi (ivi, 2013), Per Pasolini (ivi, 2014). Ha curato importanti edizioni (si ricordano, oltre a quelle tozziane, quelle di Palazzeschi apparse negli «Oscar»: Il Codice di Perelà e Interrogatorio della Contessa Maria, 2001 e 2005), antologie, cataloghi, atti di convegni e libri d’arte. Ha scritto testi scenici per Piera degli Esposti, Marco Balani, Iaia Forte e David Riondino. È autore del documentario In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi (2014). Cura un blog di poesia per “QN”. Collabora con www.pioggiaobliqua.it.
Alcuni testi qui pubblicati sono comparsi anche sul blog QN di Marco Marchi "Notizie di poesia". Essi sono proposti con il consenso dell'autore che ringraziamo per la sua collaborazione con "Pioggia Obliqua".